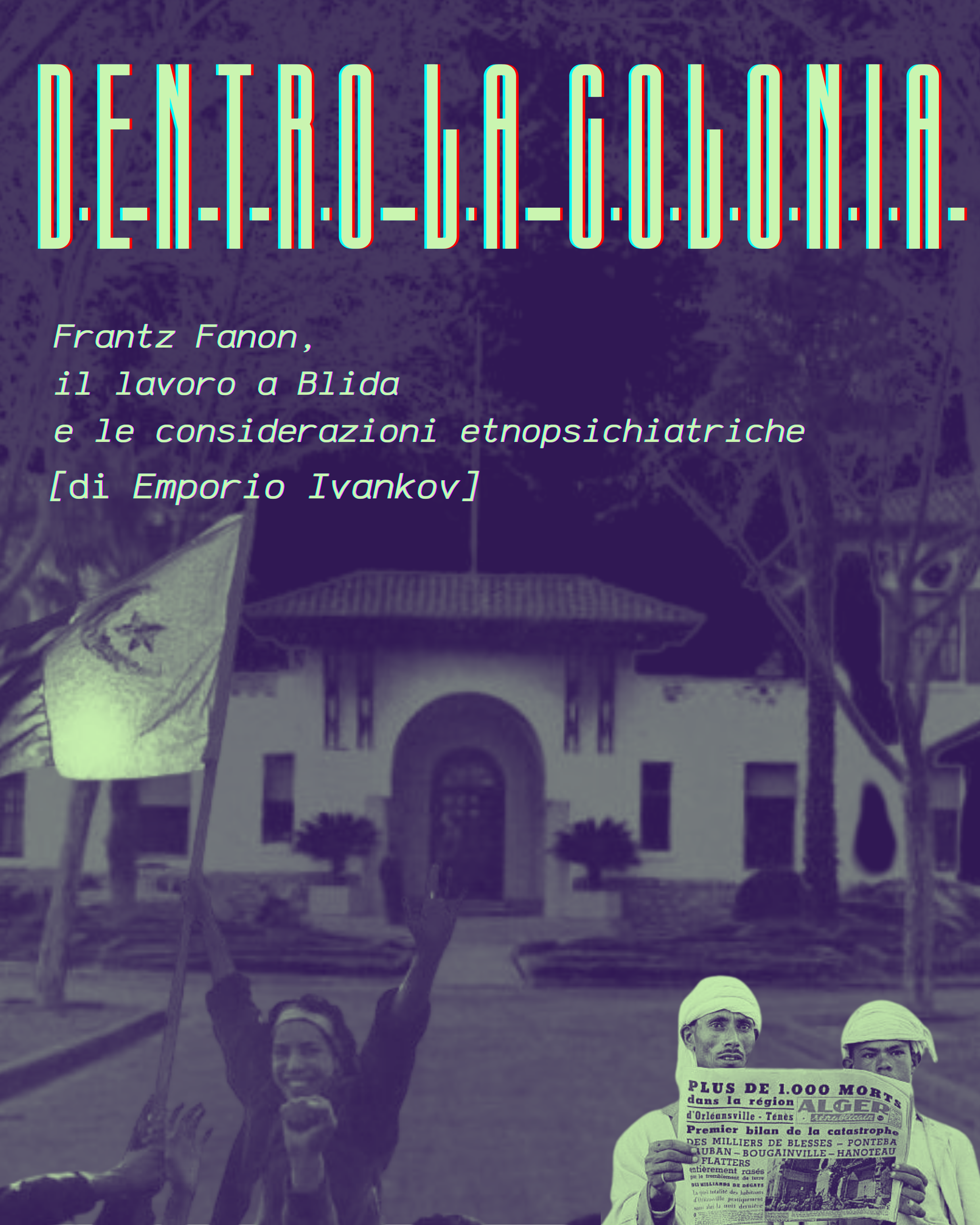
Di Emporio Ivankov
E’ il 1954 quando Frantz Fanon accetta l’offerta di un posto presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Blida, fiore all’occhiello dell’Algeria francese e roccaforte di quell’etnopsichiatria che da quasi un secolo forniva legittimazione (pseudo)scientifica all’occupazione imperialista. Sarà proprio il periodo trascorso nei territori della allora Francia coloniale che permetterà a Fanon di maturare le più dense critiche all’operato della psichiatria manicomiale europea[1]; ma in questa storia occorrerà procedere per gradi.
Non appena giunto a Blida, Fanon viene incaricato di dirigere un reparto comprendente 165 pazienti donne europee e 220 uomini musulmani[2]; in questo frangente egli avrà l’occasione di riprendere il lavoro sui laboratori di terapia sociale, maturando sino in fondo la consapevolezza della necessità di applicare non sono un’analisi, ma anche un tipo di approccio terapeutico che tenga conto dei diversi pattern culturali che incorniciano le esperienze di vita dei pazienti[3]. Il padiglione d’assistenza psichiatrica struttura il suo operato attorno ad una procedura fondamentale, le riunioni, cui medici, infermieri e pazienti prendono parte per decidere delle iniziative sociali terapeutiche[4]. Un primo banco di prova, cui mi riferisco per chiarire in cosa consistano tali operazioni, è rappresentato dall’organizzazione della festa di Natale. Lo svolgimento della celebrazione rivela immediatamente il suo carattere terapeutico:
Si prepara la festa, si diffondono gli inviti, la scena è allestita da alcuni malati con l’aiuto di una o due infermiere, e noi vi assistiamo come semplici spettatori. La festa assume allora il suo reale carattere terapeutico. Così riferiamo, come aneddoto, della scena in cui la paziente paranoica responsabile della parte cantata – Sombreros et mantillas – sorveglia con la coda dell’occhio la catatonica che tende a perdere il filo e all’occorrenza la pizzica perché si rimetta in movimento.[5]
Se queste attività si dimostrano un totale successo presso le pazienti europee, tanto da permettere la rimozione del materiale da contenzione senza temere grossi inconvenienti, esse dimostrano invece tutto il loro carattere fallimentare presso gli internati musulmani[6]. In questo caso, Fanon può constatare in primis, ancora una volta, il problema della barriera linguistica, ma, anche in seguito all’assunzione di un infermiere musulmano estremamente loquace come interprete, il disinteresse resta costante. Indifferenti alle riunioni dei comitati, manchevoli di partecipazione ai giochi collettivi, i pazienti maghrebini sembrano riservare la propria partecipazione ai soli laboratori per la produzione di indumenti. Viene dunque presa la decisione di creare un laboratorio di ergoterapia interno al servizio d’ospedale, ma i quindici malati partecipanti se ne distaccano immediatamente. Come conseguenza diretta, il personale infermieristico perde totalmente la motivazione e utilizza l’isolamento forzato come pratica di sorveglianza o addirittura di punizione. La mancata riuscita dell’instaurazione di un clima terapeutico porta con sé la necessità d’indagine delle cause che hanno condotto al fallimento. Ciò riporta Fanon ad approfondire le dinamiche culturali che regolano la vita del paziente nordafricano. Già in precedenza, durante gli anni della formazione, egli aveva ribadito la necessità di una diagnosi situazionale. L’indagine sociale si rivela infatti imprescindibile nel percorso che permetterà al giovane psichiatra di trarre dei risvolti positivi da una tale esperienza fallimentare[7]:
A Causa di quale errore di giudizio avevamo potuto immaginare una terapia sociale di ispirazione occidentale in un servizio di alienati musulmani? Come era possibile un’analisi strutturale se mettevamo tra parentesi il contesto geografico, storico, culturale e sociale?[8]
I mancati successi nel percorso terapeutico sembrano essere la causa diretta dell’assunzione di un punto di vista strettamente occidentale. Rapportandosi al paziente in maniera “neutrale”, mancando di tenere conto delle specificità culturali che caratterizzano la sua persona nel contesto d’insieme, non era possibile cogliere nel paziente ciò che Fanon definisce «il fatto sociale nordafricano». Il martinicano accorda al colonialismo un ruolo di primo piano nella genesi sociale della follia, e si addentra nelle specificità del vissuto nordafricano per cercare di intuire gli errori commessi nei laboratori di terapia sociale. Lo spunto di riflessione gli viene fornito dall’arrivo di un orchestra musulmana presso il padiglione europeo:
Nell’arco di sei mesi le donne musulmane hanno regolarmente assistito alle feste date nei padiglioni europei. Per sei mesi, hanno applaudito all’europea. E poi, un giorno, è venuta in ospedale un’orchestra musulmana, ha suonato e cantato, e fu grande la nostra sorpresa nel sentire gli “applausi” tipici delle donne musulmane: modulazioni corte, acute e ripetute. Le pazienti europee reagivano quindi a quella particolare configurazioni (adattandosi senza difficoltà) alle esigenze caratteristiche del nuovo contesto. Diventava evidente che bisognava cercare le configurazioni che avrebbero facilitato di volta in volta reazioni già iscritte in personalità già sviluppate. Una terapia sociale poteva essere possibile solo nella misura in cui si sarebbe tenuto conto della morfologia sociale nel suo insieme e delle peculiari forme di socialità.[9]
Ritengo che questa intuizione, impossibile da realizzare senza un’indagine condotta su più piani intrecciati, sia esplicativa del valore fondamentale che il pensiero fanoniano conserva ancora oggi nell’analisi della follia generata dal potere coloniale – addietro – così come dal retaggio coloniale in tempi odierni. La società maghrebina, ci dice, è una società gerontocratica. Interi villaggi facenti capo alla Djema, consiglio decisionale con alla testa un presidente, si organizzano su base clanica o familiare. Vi sono però una moltitudine di specificità che caratterizzano l’area e si traducono in altrettante differenze linguistiche e culturali[10]. Il quadro tracciato sin qui da Fanon basta a dare idea di una società complessa e profondamente differente dallo stato nazione europeo; anche se un’altra precisazione risulta fondamentale: «prima della conquista francese, la terra era proprietà collettiva»[11], solo in seguito alla conquista francese questa è stata frazionata e ripartita tra diversi titolari, diventati poi proprietari terrieri. In precedenza, il concetto di ricchezza era saldamente legato «all’idea di utile»[12]ed i possessori del terreno risultavano essere coloro i quali avevano disponibilità di strumenti da lavoro agricoli[13]. L’avvento del periodo coloniale e la redistribuzione della terra comune hanno un effetto distruttivo sull’omogeneità della società araba: oltre ad una ristretta minoranza di grandi proprietari, musulmani ed europei, vi troviamo una moltitudine di fellah, piccoli proprietari terrieri che coltivano faticosamente ristretti appezzamenti di terreno. Essi non rappresentano però “l’ultimo gradino” della scala sociale, dal momento che ad invidiare le loro condizioni troviamo un altrettanto cospicuo numero di indigenti, che non hanno potuto trarre beneficio dalle distribuzioni e che adesso cercano di affittare il proprio lavoro come braccianti. Molti di loro, rimanendo senza impiego, restano indigenti e vanno ad ingrossare le fila di un ceto che, in mancanza di qualsivoglia processo d’industrializzazione, si configura come sottoproletariato[14]. Così anche le tribù nomadi, che avevano conservato una funzione chiave nel mantenimento dell’equilibrio sociale maghrebino, vanno incontro ad una metamorfosi che passa per la sedentarizzazione. Una volta immobilizzate, esse sono costrette a vendere stagionalmente il proprio lavoro, andando incontro ad un processo di (sotto)«proletarizzazione»[15]. Ogni componente della società giunge dunque incontro a quel processo di «dissociazione» che caratterizza la genesi della follia, il profilamento degli internati nordafricani presso il padiglione di Blida lo dimostra:
Su 220 malati, possiamo trovare: 35 fellah, ovvero proprietari di un piccolo terreno coltivato da essi stessi; 76 lavoratori agricoli mezzadri o braccianti; 78 operai (panettieri, imbianchini ecc…); 5 intellettuali; 26 disoccupati. Queste cifre vanno interpretate. Si può pensare che esista un numero relativamente elevato di operai: 78 su 220. In realtà, più esattamente, si tratta spesso di quegli elementi strappati alle campagne che riescono a trovare in città un lavoro manuale in una qualsiasi attività. (…) Tali problemi hanno un’importante risonanza: gli individui che abbandonano individualmente la società tradizionale non sono quantificabili, ma il loro numero è in continuo aumento. Questi elementi costituiscono le forze, ancora poco analizzate, che stanno frantumando gli ambiti domestici, economici e politici, questa società, che noi definiamo immobile, in realtà è fermento nelle sue fondamenta.[16]
È così che si fa strada in Fanon una risposta degna di sormontare l’insieme di queste problematiche. Per avere successo, la terapia deve andare incontro al pattern socio culturale che compone una determinata società: ecco che l’istituzione di un caffè moro, la regolare celebrazione delle feste islamiche e le riunioni intorno a un «”narratore” professionista» garantiscono un consistente aumento dei partecipanti alle attività terapeutiche.
Nonostante il tentativo di trovare una soluzione si sia, in ultima analisi, rivelato fruttuoso, le condizioni infrastrutturali che parzializzano il sistema medico europeo rendendolo strumento del potere coloniale si rivelano essere un problema insormontabile. L’esperienza di Fanon presso l’ospedale di Blida non aveva fatto altro che accertare come l’alienazione fosse causa diretta dell’oppressione coloniale. Lo stallo sanguinante in cui la società maghrebina si ritrovava era specchio della volontà occidentale di mantenere la situazione immutata, e, quando i disordini rivoluzionari giungeranno a Blida, starà a Fanon lottare per cambiare le cose. Dopo essere entrato in contatto con alcuni dei dirigenti del Fronte di Liberazione Nazionale, movimento indipendentista d’ispirazione marxista che si battè per l’indipendenza nazionale, Fanon conduce un primo periodo di lavoro clandestino presso il padiglione algerino. Al termine di questo periodo, conscio di non poter ottenere risultati degni di nota in un sistema d’istituzione medica occidentale, Fanon rassegna le dimissioni dall’ospedale di Blida e si stabilisce a Tunisi, sede del movimento indipendentista algerino, dove ha inizio la sua attività clandestina presso l’organo di stampa ufficiale dell’FLN, “El Moudjahid”[17]. Il passaggio istituzionale al campo rivoluzionario appare inevitabile: uscire dall’alienazione significa in primis riappropriarsi di uno spazio che ormai è, in ogni suo aspetto, sistematica disumanizzazione[18].
Ellena, L., Profilo biografico di Frantz Fanon, in Fanon, F., I dannati della terra.
Fanon, F., Comptes rendus du Congrès des médicin aliénistes et neurologues de France ed des pays de langue française, Masson, Paris 1956.
Fanon, F., I Dannati della Terra, Giulio Einaudi, Torino, 2007.
Fanon, F., Decolonizzare la follia. Scritti sulla psichiatria coloniale, Ombre Corte, Verona, 2020.
Fanon, F., Scritti politici per la rivoluzione africana, DeriveApprodi, Roma, 2006.
[1] Ibidem.
[2] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 137.
[3] Fanon, F., Comptes rendus du Congrès des médicin aliénistes et neurologues de France ed des pays de langue française, Masson, Paris 1956; traduzione italiana in Decolonizzare la follia, op. cit. p. 181
[4] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. pp. 139-141.
[5] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 139.
[6] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 140.
[7] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 155.
[8] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 146.
[9] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 147.
[10] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. pp. 148-149.
[11] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 149.
[12] Ibidem.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. pp. 149-151.
[16] Fanon, F., Decolonizzare la follia, op. cit. p. 151.
[17] Ellena, L., Profilo biografico di Frantz Fanon, in Fanon, F., I dannati della terra, op. cit. pp. XXXI-XXXII.
[18] Cfr. Fanon, F., Scritti politici per la rivoluzione africana, DeriveApprodi, Roma, 2006.
