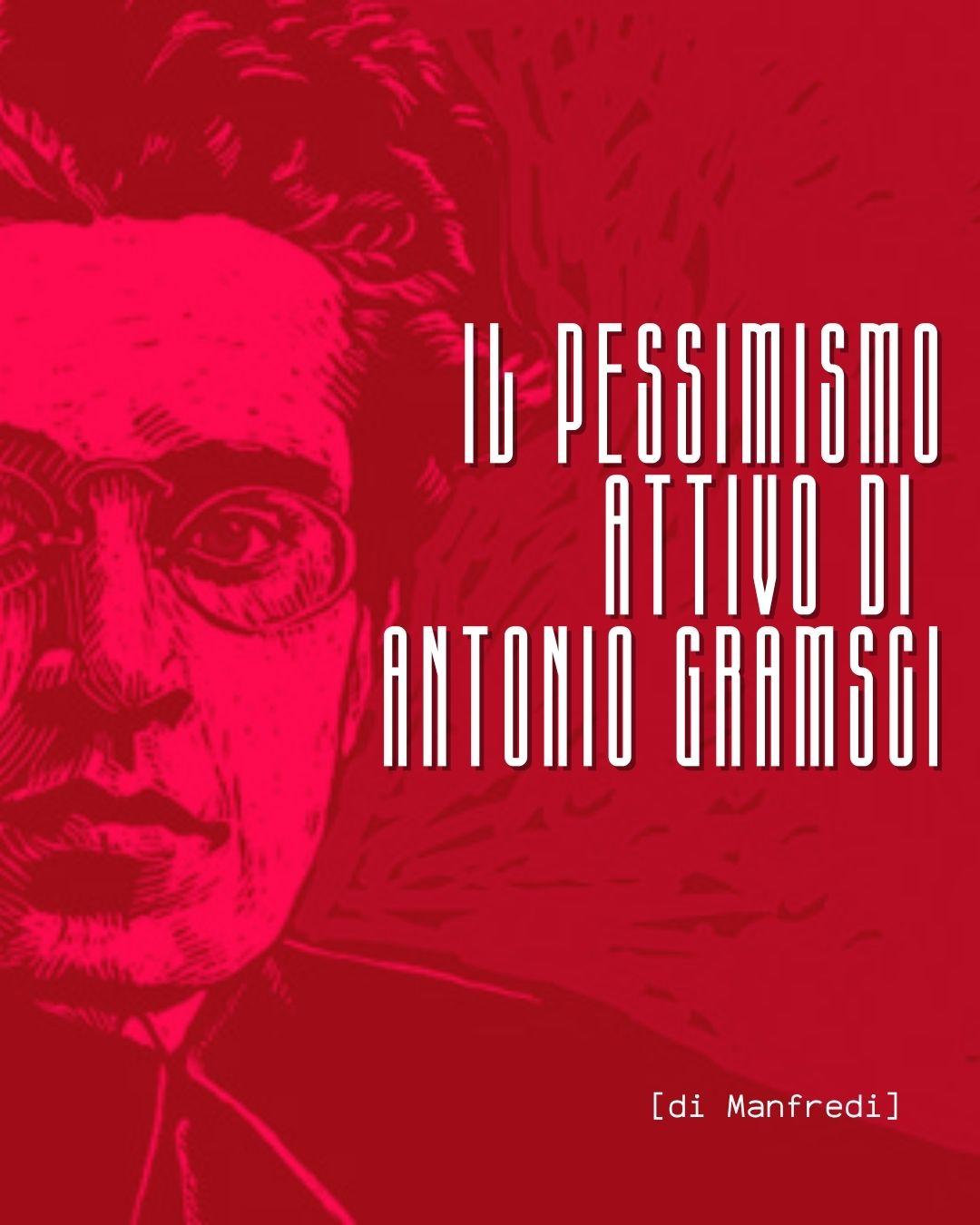[Commento all’articolo “Labriola e il senso della storia”, di Manfredi]
A quali condizioni è possibile trovare nella storia una vera conoscenza? La storia ha un senso senza risultare teleologica? In che modo la conoscenza che si trae dalla storia può essere uno strumento utile nell’azione politica?
Di fonte a queste tre domande ugualmente impegnative, e su cui hanno riflettuto generazioni di filosofi e di storici, è difficile non trovarsi in soggezione. Oggi, in un periodo in cui il relativismo e il rifiuto della cosiddetta “Grand Theory” dominano le scienze storiche, ci vuole molto coraggio a porsi queste domande in controtendenza rispetto alla regnante anarchia postmoderna. Questo coraggio non manca sicuramente a Manfredi, autore dell’Articolo “Labriola e il senso della storia”, pubblicato qualche giorno fa su Area Scettica.
Manfredi tenta di rispondere a queste domande partendo per l’appunto da Labriola, autore a lui caro e che dimostra di conoscere in modo approfondito. Non si tratta di una conoscenza erudita che sfodera possenti citazioni, ma è piuttosto una conoscenza critica, che individua anche i limiti interpretativi e che opera delle comparazioni fruttuose. Forse, se si deve individuare un limite nell’impostazione generale dell’articolo, questo risiede nella mancata contestualizzazione dell’autore (dell’epoca e del panorama intellettuale in cui scrive). D’altro canto, non si tratta di una mancanza voluta, bensì obbligata a causa del taglio dell’articolo. Per questo motivo non si può recriminare nulla all’autore, che ha invece il merito di aver riassunto in così poco spazio problemi molto estesi e complessi.
L’articolo di Manfredi cerca di inquadrare il pensiero di Antonio Labriola, appoggiandosi all’interpretazione che ne dà Alberto Burgio, introducendo i lettori a un dibattito tutto interno alla filosofia della storia. Per uno storico che non ha padronanza del linguaggio proprio delle scienze filosofiche è alquanto difficile orientarsi in simili problemi, ma il breve saggio di Manfredi rende comprensibili e accessibili questi contenuti. Si tratta, pertanto, di un contributo fondamentale per tutti gli storici che non vogliono limitarsi a registrare fatti e produrre tassonomie, ma che cercano, invece, di inquadrare i fatti in una cornice interpretativa coerente.
Totalità, storia globale e monismo
L’articolo principia con la distinzione labriolana di storia a parte obiecti e a parte subiecti (l’arcinota distinzione tra Geschichte e Historie, messa in crisi a metà Settecento proprio dall’irruzione della filosofia della storia). Secondo l’autore, la narrazione storica (storia a parte subiecti) si fonda, e deve fondarsi, sulla storia a parte obiecti, concepita come una totalità. Il recupero della categoria hegeliana di totalità è fondamentale per Labriola quanto per Marx perché permette di concepire il processo storico nel suo complesso, ricercando, per ogni evento, il principio genetico (l’origine) in un complesso di fattori che non possono essere slegati gli uni dagli altri. In parole povere: la storia è una sola, “totale” o “globale”. All’interno di questa possiamo fare dei tagli e “astrarre” un campo di indagine (che sia una determinata epoca, un paese, o una disciplina), ma fuori dall’infinità di interrelazioni che uniscono in modo inscindibile la società umana, queste “astrazioni” non hanno alcun senso. Non solo perché, per esempio, la “storia economica” non è in grado di dirci nulla fuori dal suo collegamento con la storia politica, delle idee ecc., ma anche perché non ha alcun senso fuori dalla storia tout court, fatta da persone realmente esistite che non sono solo homines oeconomici.
Il recupero della storia “totale” non deriva dall’esigenza di spiegare “tutto” con “tutto”, sarebbe impossibile. Lo nota anche Manfredi che sottolinea, riprendendo Engels, i limiti della conoscenza: “la conoscenza è conoscenza umana e ha come limite i limiti di una umanità non eterna, chiusa nei confini di ciò che può raggiungere”.[1] Ma riconoscendo i limiti di questa conoscenza, e con l’ausilio di un po’ di ingegno, si può ben tentare di ricostruire collettivamente dei quadri interpretativi complessivi. Non tanto per il gusto di elaborare una “teoria del tutto” (non è proprio questo l’intento), ma per la semplice osservazione che le categorie e i modelli interpretativi specifici che elaboriamo astraendo, hanno una coerenza solo se messi a sistema e connessi a un quadro di insieme, alla storia totale.
La totalità, correttamente ripresa da Labriola e da Manfredi, si rivela un incredibile antidoto allo strutturalismo, che era penetrato persino nel marxismo grazie al contributo di Althusser. Se si concepisce la storia nel suo processo totale, non c’è il rischio di isolare “metafisicamente” alcuna struttura (società, modo di produzione, sistema o dir si voglia), analizzandola esclusivamente secondo le sue dinamiche interne come un sistema chiuso. Non solo perché esiste un “prima” ed esiste un “altrove” per ogni società, ma anche perché il limite evidente di questo approccio alla storia è quello di concepire staticamente ogni struttura evitando, consapevolmente, la domanda fondamentale della storia, ovvero “come l’umanità è passata dagli uomini delle caverne all’industrialismo e al post-industrialismo moderni”.[2] Il recupero della totalità, in altre parole, permette di rispondere alla domanda riguardante lo sviluppo complessivo dell’umanità tutta, domanda che era stata ignorata o rifiutata da altri approcci tangenti al marxismo.
Una volta scongiurato il “vizio metafisico” (astrarre senza tener presente della totalità, senza partire dal concreto per ritornare al concreto), si deve adattare anche la ricerca storica in questa direzione. Manfredi non si sofferma su queste conclusioni di Labriola esposte nel Discorrendo (nell’articolo sono presenti solo implicitamente), ma è bene sottolinearle di fronte a un pubblico di storici. L’unità della storia, il suo “monismo”, implica anche che la ricerca debba tendere al monismo; con le parole di Labriola una “tendenza critico-formale”.[3] Infatti, se per ogni disciplina è richiesta una sempre maggiore specializzazione (fino alla microstoria), questa specializzazione deve essere successivamente ricondotta a un quadro generale in modo da non cadere nel semplice empirismo. Si tratta di un’indicazione particolarmente importante oggi, in un periodo in cui l’estrema parcellizzazione della ricerca storica rischia di produrre una serie di branche non comunicanti e di compartimenti stagni. Infine, anche se oggi non sembra un rischio effettivo, Manfredi mette in guardia anche dal vizio opposto, ovvero quello dello di partire da una totalità astratta ricadendo nella “storia dimostrata, dimostrativa e dedotta”[4], slegata dall’analisi di profondità.
Manfredi ci restituisce un Labriola coerente e profondissimo, capace di analizzare e approfondire i più rilevanti problemi che riguardano il metodo e l’epistemologia storica. Un Labriola che guarda la totalità della storia e che rifiuta schematismi e dogmatismi del marxismo volgare. Un Labriola, insomma, della migliore tradizione marxista e, sotto questo punto di vista, validissimo ancora oggi.
Alcuni problemi, non partendo prevenuti
I problemi sopraggiungono solo quando si inizia a parlare di “senso” della storia e di “progresso”, due termini a cui oggi è difficile guardare senza una certa dose di scetticismo. Chi scrive questo commento però non parte prevenuto, tutto il contrario. Oggigiorno le critiche che vengono mosse alla nozione di “progresso”, nella maggior parte dei casi, sono portate avanti dai sostenitori del relativismo che rifiuta, con la nozione di progresso, anche l’accettazione di qualsiasi criterio oggettivo di verifica scientifica (tanto per i “fatti” quanto per le “interpretazioni”). Infatti, la critica al “progresso” va di pari passo con il bollare di “positivismo” qualsiasi approccio metodico e che ricerca una coerenza di qualche tipo. Se questa è la critica al concetto di “progresso” come categoria analitica per interpretare la storia, è molto debole, anzi, è piuttosto stupida. Il problema del “progresso” nella filosofia della storia (non solo del Labriola, ma di tutte le filosofie della storia), a giudizio di chi scrive, va affrontato partendo da una postura differente, senza il rifiuto del metodo scientifico, analizzando piuttosto altre debolezze strutturali implicite a questo tipo di approccio filosofico.
Manfredi, riprendendo Labriola, rivendica il procedimento scientifico di “astrarre” “forme preminenti” o “momenti decisivi” dalla storia (a parte obiecti) per fornire un modello interpretativo che sia in grado anche di indicare “tendenze e direzioni”. Si tratta, per inciso, dell’“astrazione determinata” che Marx indica come il metodo corretto per approcciarsi allo studio della disciplina storica nella famosa Introduzione a Per la critica dell’economia politica (pubblicata postuma). L’astrazione così concepita, come base per raggiungere una sintesi superiore e una comprensione del particolare nella totalità, è un procedimento che possiamo giudicare come corretto a prescindere dalla previsione delle tendenze, ma difficilmente si può slegare da queste. Difatti, è assolutamente naturale, e in un certo modo inevitabile, rivolgersi alla storia per avere delle risposte sul futuro. Oltretutto, per quanto sia una considerazione piuttosto banale, occorre sottolineare come passato, presente e futuro formino un continuum. Se la domanda di storia guarda oltre la mera fascinazione antiquaria, è inevitabile lo sguardo verso il futuro e quindi anche l’interesse politico.
C’è però un salto logico nel ragionamento che viene proseguito. Riguardo la ricerca della tendenza, Manfredi scrive “Ciò che è implicito è che questo procedimento è sempre in funzione di una narrazione, che il lavoro scientifico sulla storia se non vuole ridursi a un metodo di elencare fatti senza renderne conto deve includere delle tesi e farsi politico: ha bisogno di astrarre un senso dalla storia.”[5] Il problema con questa proposizione è l’affermazione di una immediata identità tra narrazione (e quindi interpretazione) e punto di vista politico e ideologico.
È senz’altro vero, come ricorda Manfredi, che lo storico, e tutti gli uomini, non sono al di fuori della storia e dal contesto che li determina; che non esiste un uomo che possa dirsi super partes rispetto al processo di produzione sociale, che è anche produzione della conoscenza, e che quindi è anche una conoscenza politica, una narrazione da un determinato punto di vista. Ma ponendo in questi termini l’equazione si commette lo stesso errore di quelle posture irrazionalistiche tanto critiche verso la filosofia della storia, ovvero si rifiuta (più o meno consciamente) la possibilità – o quanto meno il tentativo – di una ricerca obiettiva che non sia anche e immediatamente politica. Ne consegue un’accettazione passiva della propria “deformazione ideologica” e si finisce in una spirale che tende a confermare le proprie tesi di partenza con una selezione interessata del materiale, operando un’astrazione che quindi non è più “determinata” ma diventa “determinante” del processo conoscitivo stesso. In altre parole, si giunge alla teleologia, e alla storia “dimostrata, dimostrativa e dedotta”.
Il problema, in realtà, si pone su diversi livelli, per cui è meglio proseguire con ordine.
La “tendenza” e il “senso”
L’analisi del continuum storico, della totalità interconnessa di passato-presente-futuro, pone degli evidenti limiti conoscitivi per l’ultimo termine della terna. Infatti, se il passato si è concluso (ed è “storia”), lo si può osservare ed analizzare in maniera sostanzialmente differente rispetto al futuro. Motivo per cui la previsione, come riconosce Manfredi, è una previsione di tendenza. Si tratta di una tendenza perché ovviamente non sono individuabili “leggi storiche” che regolano il destino umano, se non altro perché, come ricorda Marx “gli uomini fanno la loro storia”, e ne deriva un margine di possibilità ampio che deriva dall’arbitrio e dall’agire umano.
La tendenza si può comunque ricavare dall’astrazione di “forme preminenti” e “momenti decisivi”, che però sono ricavati solo dalla storia a parte obiecti, sulla quale non si può intervenire (in quanto conclusa). E questi “momenti” non derivano direttamente dall’analisi dei dati “crudi”: sarebbe ridicolo pensare che le tesi possano nascere spontaneamente dall’analisi disinteressata delle fonti. Epperò, lo statuto di veridicità dell’interpretazione della storia a parte obiecti (passata) è sostanzialmente differente rispetto alla previsione della tendenza che si può ricavare, tanto più quando questa previsione passa da essere una previsione generica a una previsione specifica.
Si tratta di un problema non solo della previsione “morfologica” – per riprendere le parole del Labriola –, ma del marxismo tutto che ha spesso ricavato un senso (o il senso) dalla storia, figurando previsioni sbilanciate in maniera fin troppo evidente verso la teleologia.
Su questo tema si espresso a più riprese Hobsbawm, il quale ha evidenziato la differenza sostanziale tra le diverse previsioni di Marx, per esempio tra quella che riguarda la tendenza all’accumulazione capitalistica e la previsione dell’avvento della società senza classi. La prima “si basa su un’analisi storico-teorica diversa e più significativa della previsione che lo stesso proletariato in quanto classe diventerà «l’espropriatore degli espropriatori». Le due previsioni per quanto connesse non sono identiche e, anzi, possiamo accettare la prima senza dover accogliere la seconda.”[6] Il problema della seconda previsione è quello già accennato sopra, quello della narrazione che si fa immediatamente politica e che “determina” la lettura della storia stessa. Si tratta del “senso” che figura aprioristicamente un esito della tendenza e che impedisce di considerare altre alternative, che pure sono sempre possibili. Invece, la prima delle due previsioni, come molte altre categorie analitiche che derivano dall’astrazione marxiana, conserva una propria validità in quanto “scientifica”, perché deriva da un’osservazione empirica della storia e del capitalismo. Non è, infatti, necessariamente connessa con il “fine” ultimo del comunismo perché si fonda sull’analisi critica della totalità storica a parte obiecti, e non sul telos.
Concludendo su questo primo punto possiamo sintetizzare quanto segue. Il difetto dell’analisi di Manfredi sta nella sovrapposizione del “senso” specifico, politico e ideologico, con l’analisi di tendenza generale che deriva da un’analisi empirica della storia totale. La concezione materialistica della storia, invece, può e deve essere slegata da un esito teleologico (anche se lo si definisce accortamente come “morfologico”). Infatti, l’analisi della progressiva separazione dell’uomo dalla proprietà (dalle condizioni oggettive della realizzazione del suo lavoro, ovvero l’alienazione), il susseguirsi di alcuni modi di produzione (non necessariamente gli stessi indicati da Marx), le considerazioni generali sulla produzione materiale della vita come filo conduttore della storia ecc. sono tutte considerazioni che mantengono una validità nei confronti della storia a parte obiecti a prescindere dall’avvento del comunismo. Quest’ultimo rientra nell’ambito della possibilità storica, e non della necessità; e non riconoscere questa finestra di possibilità equivale a ricadere inevitabilmente nel determinismo.
Il proletariato e il relativismo storico
Il secondo problema deriva dall’individuazione di “unsenso” nella storia sulla base di un soggetto determinato, e quindi storico. Infatti, come riconosce Manfredi, un senso si può ricavare solamente relativamente a un narratore e a un punto di vista specifico e quindi a un giudizio di valore. Non si tratta, in questo caso, di un soggetto singolo (lo studioso), ma di soggetti collettivi e storici. Si tratta dunque di un relativismo rigorosamente storico che non vuole confondersi con il relativismo soggettivista irrazionalistico. Se non si può ricavare un senso prescindendo da giudizi di valore, e questi sono storicamente determinati, è evidente però, che anche lo statuto veritativo di questo senso diventa di conseguenza “storico”. Allora come è possibile ricavare un’analisi scientifica che abbia un “senso” che ci fornisca qualcosa di più di una conoscenza valida solo per l’hic et nunc? Purtroppo, non è possibile rispondere a questa domanda se si assumono queste premesse.
La rivendicata storicità del “senso” non è problematica solo rispetto al futuro, e quindi rispetto al fatto che una determinata interpretazione connessa a un senso specifico possa essere superata sulla base di un nuovo soggetto storico-sociale che ne elabora una nuova, ma è problematica soprattutto rispetto al passato. Se si estende al passato questo relativismo storico si finisce con attribuire lo stesso statuto di verità – in quanto questo statuto di verità è storico – alla teoria tolemaica e a quella copernicana perché, fino al XVII secolo, la prima aveva una validità relativa ad un momento storico, e quindi era oggettiva nel senso di “soggettivo universale” (riprendendo le parole di Gramsci). Purtroppo però, la terra non ha iniziato a girare intorno al sole dalla metà del XVII secolo.
Certo, l’impostazione del Labriola e di Manfredi non è così ingenua. Non si tratta sicuramente del materialismo storico “marxista-leninista” stampo sovietico (capace di tenere insieme allo stesso tempo lo scientismo e la teleologia, gli aspetti peggiori del positivismo e della filosofia della storia). Infatti, il materialismo storico non è concepito come “la visione mondiale scientifica della classe operaia” (riprendendo la definizione della SED). Della filosofia del Labriola si preferisce sottolineare l’elemento di “tendenza”, aperta e critica rispetto allo studio della realtà concreta e delle sue trasformazioni. Allo stesso tempo però, non è problematizzato a sufficienza il fatto di collegare la “visione scientifica” alla “classe operaia” (o ai suoi intellettuali e al suo partito), visto che questo sarebbe il soggetto storico determinato che attribuisce un senso alla storia. Anzi, nella parte finale dell’articolo sembra quasi che l’angolo visuale della classe operaia possa avere degli intrinsechi vantaggi epistemologici che possono essere universalizzati rispetto ad altri soggetti storici. Ma perché mai un qualsiasi soggetto sociale dovrebbe avere questi vantaggi? Non ci è dato saperlo.
Il “progresso”
Il terzo e ultimo problema è quello del “progresso” che, in quanto intimamente connesso a giudizi di valore, deriva direttamente dal “senso” attribuito alla storia. Come sostiene Manfredi: “Il problema del progresso è legato indissolubilmente al problema del senso della storia e in un certo senso vi si sovrappone: il progresso, sia auspicato e previsto, sia ritrovato in processi passati, è l’individuazione di un movimento in relazione a un senso.”[7] Ma il senso, come si è tentato di dimostrare, non è implicito in alcuna analisi scientifica e di tendenza, e deriva piuttosto da un’attribuzione soggettiva e storica di giudizi di valori, si tratta dunque di un progresso relativo? Non sembra che questa conclusione spaventi in alcun modo Manfredi che, anzi, rivendica la relatività di questo progresso. Il problema è, ancora una volta, il legame con l’analisi scientifica, che c’entra poco con questa connotazione del concetto di “progresso”, ma che si connette con esso attraverso l’attribuzione di un senso.
Il progresso, come sottolinea anche Manfredi, va tenuto distinto dallo “sviluppo”, che invece, secondo una serie di parametri verificabili, è riscontrabile in varia misura. Infatti, se lo sviluppo rappresenta qualcosa di puramente materiale e di per sé neutro, il progresso contiene necessariamente un giudizio di valore. Anche il progresso, come lo sviluppo, sarebbe osservabile nei processi storici. È tuttavia significativo che nell’unica sezione in cui si sviluppa il concetto di progresso, l’unico esempio che viene portato per parlare di come questo si manifesti nella realtà (in modo non lineare, con possibilità di un regresso relativo ecc.) è quello del “progresso tecnico”. Ma cos’altro sarebbe questo progresso tecnico se non uno sviluppo avalutativo?
Il problema, in ultima analisi, è lo stesso del “senso” della storia. Lo sviluppo delle forze produttive lungo il corso della storia, la trasformazione e la complessificazione dei sistemi sociali che regolano la vita dell’uomo ecc. sono fattori di sviluppo empirici della storia a parte obiecti. Le categorie analitiche del materialismo storico – la legge del valore-lavoro, la categoria di modo di produzione e di formazione sociale, l’analisi dello sviluppo del capitalismo – sono chiavi interpretative della storia a parte subiecti, discutibili e opinabili, ma scientifiche. Invece, l’idea di progresso e il senso attribuito alla storia fanno parte di un altro tipo di discorso che non è direttamente connesso all’analisi obiettiva, e che pertanto non può avere lo stesso statuto veritativo e che invece rivendica a tutti i costi.
Conclusioni, la storia e la politica
Questa impostazione filosofica rispetto al senso e al progresso ha come implicito obbiettivo quello di impostare le questioni politiche sullo stesso piano di quelle “scientifiche”. Se il senso deriva dall’analisi di tendenza e dall’analisi obiettiva, anche il progresso è ricavabile scientificamente (per quanto sia relativo a un soggetto) e ne consegue la possibilità di indicare con maggiore precisione cosa sia “progressivo” e cosa “regressivo” o “reazionario”. Ma si tratta di una pretesa non fondata, e, in ultima analisi, pericolosa.
L’approccio appena descritto ricorda, non a caso, quello che adopera Lukács nel suo Lenin dove, esaltando la figura del rivoluzionario russo, si sforza di dimostrare come dall’analisi della totalità storico-sociale derivi immediatamente tutta l’impostazione politica di Lenin (che ha solo applicato coerentemente la dialettica di Marx). Se il soggetto storico rivoluzionario è indubitabilmente il proletariato, e questo deriva da un’analisi oggettiva della realtà, anche la prassi politica conseguente, e la nozione di cosa è e cosa non è progressivo, deriva a cascata da questa analisi scientifica. Ma il salto logico, anche in questo caso, è a monte. La previsione del “proletariato” come soggetto rivoluzionario predestinato a rovesciare il capitalismo non deriva dall’analisi obiettiva della tendenza: è un’inferenza che, per quanto possa essere argomentata, non è “oggettiva” e iscritta nella storia. Ancora una volta può essere utile richiamarsi a Hobsbawm che in una recente introduzione al Manifesto del partito comunista ha approfondito questo problema. In Marx, e di conseguenza in buona parte del marxismo successivo, l’analisi del proletariato come soggetto storico della rivoluzione deriva “da un argomento filosofico, anzi escatologico, sulla natura e il destino umani.”[8] Infatti, se si segue filologicamente lo sviluppo del pensiero di Marx, questo giunge prima al comunismo e al proletariato, e solo dopo al materialismo storico e all’analisi scientifica del “mondo delle merci”. Per questa ragione si può e si deve distinguere tra questi due ordini di discorso differente.
Se quindi può essere legittimo, per quanto arbitrario, stabilire che per un determinato soggetto storico (come la classe lavoratrice) esista un criterio di valore che indica cosa è progressivo e cosa no; non è legittimo sostenere che questo sia scientifico, neanche con tutte le accortezze del caso. Oltretutto, come accennato prima, si tratta di un procedimento molto pericoloso perché, come è già successo in alcuni casi estremi, può minare le fondamenta stesse della ricerca scientifica. È il caso dell’approccio ždanoviano che postulava una totale congruenza tra affermazioni politiche e scientifiche e, quindi, una virtuale intercambiabilità delle proposizioni di entrambe le forme a qualsiasi livello di discorso. Questo si basava sulla considerazione che non esistesse un campo specialistico per il discorso scientifico né un pubblico specializzato per questo tipo di discorso, e finiva con l’attribuire la virtuale superiorità dell’autorità politica su quella scientifica. Non è difficile dedurre la ragione dell’irrigidimento ideologico che, in Unione Sovietica, stritolò il marxismo in un letto di Procuste dogmatico e soffocante.
Queste considerazioni sul progresso e sui limiti teleologici dell’articolo di Manfredi non vogliono però concludere che la storia non serva alla politica, tutt’altro. Chi scrive è un fervente sostenitore della lotta dei lavoratori e degli sfruttati, e si è sempre schierato con loro in prima linea. In questa lotta la conoscenza della storia, così come dell’economia, della filosofia, ecc. è fondamentale perché permette di fondare su basi solide un progetto politico e di rottura. Lo ricorda ancora una volta Labriola: “La conoscenza del passato giova ed interessa praticamente, solo in quanto essa può dar luce e orientazione critica a spiegarsi il presente.”[9] Ma questo non vuol dire che si possa ricavare un “senso” e un “progresso” immanente alla storia e che questo debba guidare le nostre scelte politiche. Se vogliamo che la storiografia ci guidi nel giudizio – questa volta sì, di valore – del presente, dobbiamo far sì che rimanga una scienza, con parametri propri di analisi e criteri di verifica forti. Solo così può illuminarci nella lettura del presente e nella progettazione del futuro.
[1] Manfredi, Labriola e il senso della storia, in Area Scettica (cap. 2)
[2] Eric J. Hobsbawm, De Historia, Rizzoli, Milano, 1997, p. 96
[3] Labriola, Discorrendo di socialismo e filosofia, in Saggi sul materialismo storico, Editori Riuniti, Roma, 1964, p. 222
[4] Labriola, Del materialismo storico. Dilucidazione preliminare, in Saggi sul materialismo storico, p. 93
[5] Manfredi, Labriola e il senso della storia, Area Scettica (cap. 2)
[6] Eric J. Hobsbawm, De Historia, p. 57
[7] Manfredi, Labriola e il senso della storia, Area Scettica (cap. 6)
[8] Eric. J. Hobsbawm, Come cambiare il mondo, Rizzoli, Milano, 2011, p. 122
[9] A. Labriola, In memoria del manifesto dei comunisti, in Saggi sul materialismo storico, p. 62