Analogia e ripetizione, guerra e trasformazione
Di Gervasio
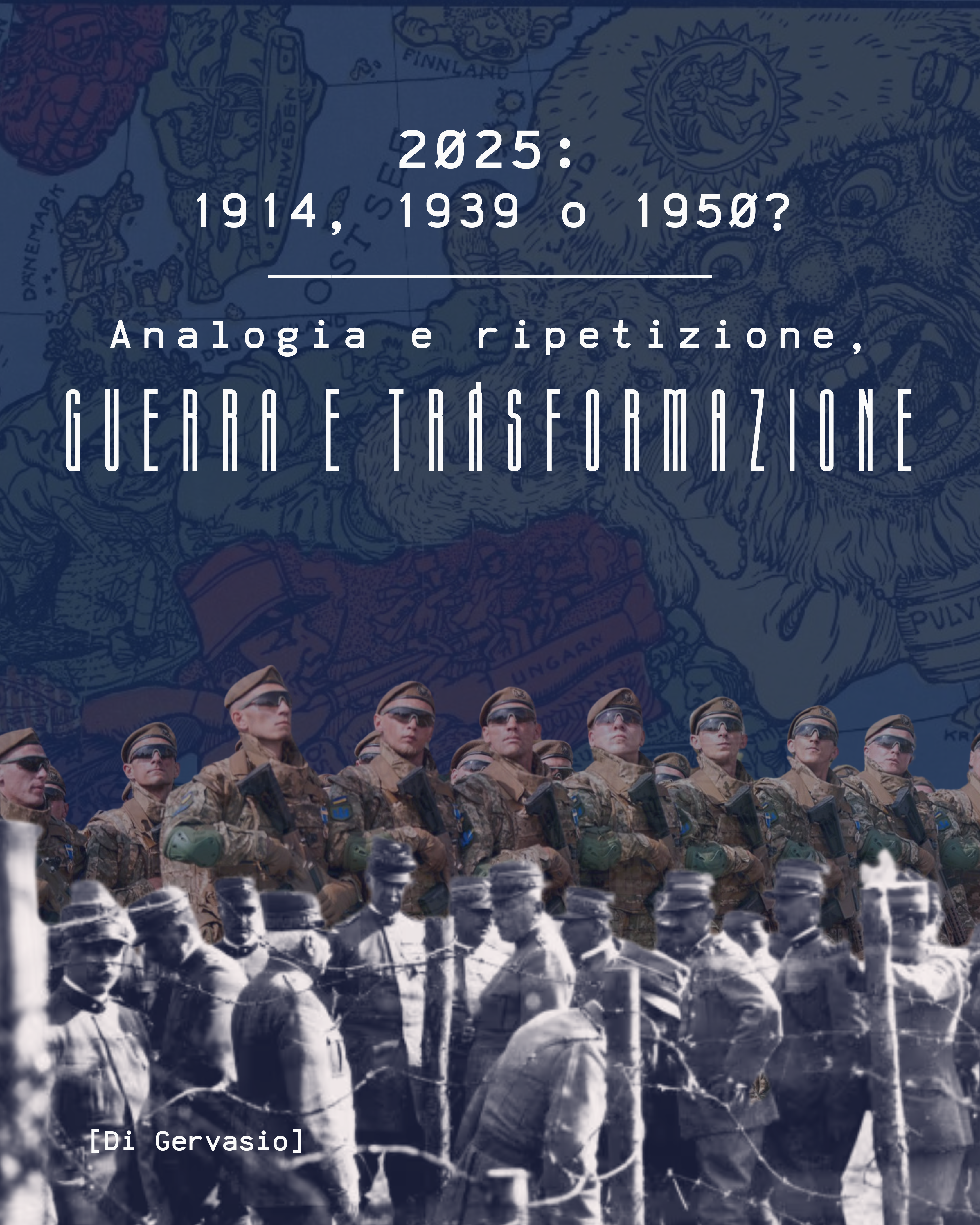
Chi scrive non ha mai sopportato l’utilizzo aforistico della formula “la storia si ripete”: l’esempio da manuale della frase fatta per ogni evenienza, apparentemente piena di significato, nella sostanza un semplice motto. Questa espressione, una sorta di parafrasi impropria e monca dell’incipit del 18 Brumaio[1], ha perso qualsiasi attinenza con la citazione originaria. Chi ripete questa formula propone una chiave interpretativa semplicistica di una vasta gamma di eventi storici funesti – guerre, crisi, dittature –, sostenendo implicitamente che il loro ripresentarsi sia un fatto normale ed ovvio. Si isola un determinato fenomeno, lo si astrae dal suo contesto e dalle caratteristiche peculiari, si registra la sua ripetizione nel corso di un certo periodo di tempo e lo si eleva a regola generale. La storia si presenta come un “eterno ritorno dell’uguale”, e la cosa più inquietante è che si ricavi questa mostruosità da Marx, il cui pensiero rappresenta l’antitesi per eccellenza alla naturalizzazione di qualsiasi fenomeno storico. Quando si abbina “la storia si ripete” a “corsi e ricorsi storici”, chiamando in causa anche il padre della tradizione storicistica moderna, si raggiunge la follia pura e si travalica – questa volta per davvero – dalla tragedia alla farsa.
Il fatto che alcuni giornalisti mediocri adoperino queste espressioni, però, ci deve far riflettere sul significato della ripetizione nella storia. Ogni storico dovrebbe sapere che la storia “non si ripete” perché le circostanze non sono mai le stesse, eppure alcuni elementi comuni in momenti abbastanza distanti nel tempo si possono ripresentare. Individuare la ripetizione di alcuni fenomeni, e quindi proporre delle analogie, è addirittura uno dei principali metodi che permette allo storico di cogliere i nessi causali e di interpretare il susseguirsi degli eventi. Il problema sta nelle circostanze differenti sullo sfondo che spesso implicano esiti difformi. Dunque, non è sbagliato ricercare la ripetizione o la periodicità, ma l’astrazione dal contesto storico peculiare, cosa che comporta inevitabilmente la banalizzazione.
Negli ultimi tre anni, i media e gli “esperti” di geopolitica hanno ciclicamente riproposto alcune analogie mettendo in relazione lo scenario di guerra odierno con alcuni conflitti della storia del ‘900. C’è chi ha parlato di una “seconda guerra fredda” e chi, dal lato opposto, ha interpretato lo scenario internazionale come il ripetersi delle rivalità imperialistiche della Prima Guerra Mondiale. C’è addirittura chi ha definito Putin come “il nuovo Hitler”, con un implicito riferimento alla Seconda Guerra Mondiale. In tutti questi casi si è tentato di scorgere elementi comuni tra la situazione presente e una guerra del passato con l’obbiettivo di dare un senso al confitto odierno. Ovviamente, a differenza della comparazione di due eventi passati di cui si conoscono gli esiti, l’analogia tra passato e presente non è funzionale alla mera interpretazione storica, ma ha diversi obbiettivi. Per chi la utilizza con fini propagandistici serve a legittimare determinati disegni politici, per chi si approccia criticamente alla storia serve a ipotizzare possibili evoluzioni del presente. Per questo motivo, al netto di come vengono tracciate le analogie da certi commentatori, si tratta di una operazione non solo legittima, ma persino necessaria per chi si pone l’obbiettivo di trasformare la realtà e non solo di interpretarla.
Per evitare che l’azione politica si fondi esclusivamente su pulsioni ideali e progetti utopistici, tutti i movimenti sociali che si sono sviluppati a partire dalla metà dell’Ottocento hanno ritenuto fondamentale partire dall’“analisi concreta della situazione concreta”. Indipendentemente dal fatto che questi movimenti si richiamassero a Marx o meno, il loro “successo” è sempre dipeso dalla lucidità di analisi e dallo studio della storia. La comprensione degli elementi comuni ci permette di far luce sul presente e di intravedere possibili sviluppi futuri. Proprio perché nessuna evoluzione storica è predeterminata, e quindi la storia non “si ripete” inevitabilmente, non si deve ricercare l’analogia per preconizzare finalisticamente un esito necessario, ma si deve tentare di cogliere la somiglianza per intervenire meglio nel nostro tempo.
L’analisi comparata tra i conflitti mondiali del Novecento e l’escalation degli ultimi quindici anni può gettare luce su quest’ultima. Non si tratta qui di stabilire quale dei vari contesti bellici assomigli “di più” al nostro presente, ma di individuare alcuni elementi di ricorrenza in modo da tentare di elaborare una strategia per l’azione politica oggi. Per questo motivo, una volta individuati i tratti comuni, è necessario anche recuperare le riflessioni di chi, partendo dalla nostra stessa prospettiva trasformativa, sviluppò riflessioni utili per problemi politici che si ripresentano, mutatis mutandis, nel 2025.
Sono tre i momenti più significativi che presentano delle analogie con il contesto di guerra odierno: la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra fredda. Per questo motivo nel proseguo dell’articolo ci si soffermerà su questi tre momenti fondativi del nostro presente e sulle analogie che si possono tracciare. Contemporaneamente, si recupereranno le riflessioni di alcuni tra i più importanti commentatori e militanti politici che operarono in quei contesti in modo da individuare cosa può tornarci utile tra quello che hanno ancora da dirci.
1914
Il ventennio antecedente allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è sicuramente il momento storico che si presta meglio all’analogia con la situazione odierna. Dopotutto tracciare un parallelismo tra il 1914 e il 2025 mentre una potenza economicamente dominante in declino viene “sfidata” dal gigante industriale in ascesa è fin troppo facile. Non è opportuno esagerare la somiglianza tra la situazione internazionale della belle époque e quella contemporanea, soprattutto per l’assenza del mondo coloniale propriamente detto[2], ma fatta questa accortezza ci sono numerosi elementi che si ripresentano quasi specularmente. Un elemento di estrema attualità, per esempio, è la notevole flessibilità delle alleanze politiche internazionali che permette improvvise fratture o riallineamenti (si allude non solo alle svolte della politica americana, ma anche alle contraddizioni nel campo dei “BRICS”). Questa fluidità degli schieramenti in gioco si sposa bene con la mancanza di forti ragioni ideali che muovono le parti in lotta. Al contrario della Seconda Guerra Mondiale o della Guerra fredda, infatti, le ragioni del conflitto sono meno marcatamente ideologiche. La contrapposizione democrazia-autocrazia è limpidamente pretestuosa, come lo era d’altronde nel ’14-’18; per converso, non si può dire che la “democratizzazione delle relazioni internazionali” mobiliti i cuori dei rivoluzionari come il sogno di una società comunista durante e dopo il secondo conflitto mondiale. Inoltre, lo scacchiere internazionale non presenta due o tre attori protagonisti attorno a cui ruotano dei campi grossomodo definiti: l’esistenza di soggetti più forti si inserisce nel quadro di un panorama frammentato dove anche le più solide alleanze storiche sono messe in discussione. Fatti e considerati tutti questi parallelismi non stupisce neppure come nella stessa propaganda di guerra si possano addirittura intravedere gli stessi motivi polemici. Il più eclatante è la contrapposizione fittizia aggressore-aggredito, il leitmotiv del dibattito sull’Ucraina.
Un ultimo elemento che permette l’analogia, probabilmente quello più rilevante, riguarda lo squilibrio economico mondiale che non riflette più i rapporti di forza politici di partenza. L’analogia in questo caso non può essere tracciata in senso economicistico, se non altro perché lo squilibrio debitori-creditori come si è presentato tra Stati Uniti e il mondo non allineato alla vigilia della svolta protezionistica statunitense non ha un precedente nel primo conflitto mondiale. Il legame sta piuttosto nel cambiamento di peso di alcune economie in ascesa rispetto alla crisi della potenza egemone che controlla la valuta di riserva mondiale. Nel 1914 si presentò una stridente contraddizione tra l’equilibrio politico che era stato imposto e mantenuto, economicamente e manu militari, e la crescita dirompente della Germania guglielmina che, reclamando una nuova ripartizione delle colonie, mise in crisi la pax britannica; la stessa cosa sta succedendo oggi tra Stati Uniti e Brics (e in particolare con la Cina). Non è un caso che, con l’aggravarsi delle tensioni, la diplomazia internazionale diventi schiettamente sincera sulle ragioni economiche del conflitto (un caso emblematico è il tentativo di accordo per le terre rare).
La predominanza dell’interesse economico-politico alla base dei progetti imperiali dei vari attori internazionali permette di recuperare le analisi che i socialisti europei elaborarono durante il conflitto. Non è un caso che il celebre opuscolo di Lenin “L’imperialismo, fase suprema del capitalismo” sia stato riconsiderato da importanti economisti contemporanei come Emiliano Brancaccio, autore di “La guerra capitalista” (2023). Un po’ meno noto, ma altrettanto significativo, è l’opuscolo “Il socialismo e la guerra”, scritto sempre da Lenin nel 1915. In questo pamphlet, oltre all’analisi della situazione internazionale dalla prospettiva dei socialisti, sono proposte delle interessantissime considerazioni politiche. In primo luogo, mettendo in evidenza il carattere inter-imperialistico della guerra, si prende atto del fatto che non ci sia uno schieramento “progressivo” per cui patteggiare: in una guerra per la “spartizione degli schiavi”, non si può simpatizzare per nessuno schiavista. Dopo l’accettazione dei crediti di guerra da parte dei partiti socialisti europei e del loro scivolamento nazionalistico non si trattava di una presa di posizione scontata. In secondo luogo, per quanto riguarda la prassi politica, Lenin sottolinea l’importanza di opporsi al proprio governo (il nemico interno) come priorità per ogni partito rivoluzionario. Infine, viene sottolineata la necessità di sfruttare la situazione di tensione per “trasformare la guerra imperialista in una guerra civile”, e quindi di spostare l’asse del conflitto da nazione-contro-nazione a classe-contro-classe. Fatti i necessari aggiustamenti, rimangono considerazioni preziosissime. La situazione di crisi internazionale ci deve portare a considerare come prioritaria la lotta contro la guerra, e nel nostro paese i principali responsabili dell’escalation sono i partiti di governo che si sono susseguiti, dal Partito Democratico a Fratelli D’Italia, indipendentemente dalle particolari simpatie internazionali che possono avere. L’imprescindibile opposizione al nemico interno, italiano ed europeo, rappresenta la linea di confine della battaglia politica che bisogna combattere: la barricata deve essere eretta tra chi vota i crediti di guerra e chi li rifiuta, non tra l’occidente e l’oriente.
Un ultimo appunto. Si è detto che il procedimento analogico ci deve servire anche per tentare di avanzare delle ipotesi su possibili sviluppi futuri. Nel corso della storia chi ha tentato di prevedere le possibili evoluzioni ha sbagliato clamorosamente nella maggior parte dei casi, tuttavia ci sono delle eccezioni significative. Il caso più eclatante è quello del dibattito politico immediatamente precedente alla Grande Guerra. Non solo i socialisti, ma un nutrito gruppo di commentatori si accorse della prevedibilissima piega che avrebbe potuto prendere la rivalità tra le potenze europee. A tal proposito nel 1894 Max Weber ebbe a scrivere “solo una totale cecità politica e un ingenuo ottimismo possono impedirci di capire che gli inevitabili sforzi di espansione commerciale compiuti da tutti i paesi civili dominati dalla borghesia, dopo un periodo transitorio di concorrenza apparentemente pacifica, si stanno chiaramente avvicinando al punto in cui soltanto la forza deciderà la parte di ciascuna nazione nel controllo economico della terra”. In virtù dell’analogia appena tracciata, non è un’assurdità ipotizzare degli esiti simili. Tuttavia, come accennato precedentemente, la situazione attuale presenta somiglianze anche con altri scenari conflittuali che ci sono familiari, per cui, per non trarre conclusioni affrettate, occorre analizzare le caratteristiche comuni che presentano gli altri contesti bellici del ‘900 con la situazione attuale.
1939 (1922)
Il paragone con gli anni ’30 del XX secolo, come antefatto alla Seconda Guerra Mondiale, è meno calzante di quello proposto nel capitolo precedente. Soltanto chi si rifiuta aprioristicamente di sedersi al tavolo delle trattative di pace può sostenere che Putin abbia le stesse ambizioni di vittoria totale e di sterminio proprie della Germania nazista, e in tal senso, l’analogia non si presta. Tuttavia, alcune caratteristiche ricorrenti con il ventennio antecedente al secondo conflitto mondiale si possono individuare, soprattutto per quanto riguarda l’orientamento politico “interno” dei paesi occidentali.
Non si vuole sostenere che l’impetuosa avanzata della destra rappresenti l’antefatto del ritorno del “fascismo”. Questo argomento, che ha come unico scopo la mobilitazione verso le urne del ceto-medio progressista, non ha particolare fondatezza in ambito storiografico. Al contempo però, non è questionabile il fatto che in tutti paesi occidentali, e in buona parte di quelli extra-occidentali, si stiano affermando governi di estrema destra che ricalcano le stesse posizioni reazionarie caratteristiche dei movimenti fascisti della prima metà del ‘900. Dal punto di vista del conservatorismo sociale e dell’orientamento ultranazionalista e antipopolare, e del suprematismo bianco, non pare che ci siano differenze così significative in termini valoriali rispetto ai loro progenitori del secolo scorso. Anzi, per molti partiti di estrema destra il richiamo al passato fascista è esplicito e rivendicato. In che termini, dunque, si può parlare di “fascismo”? Il problema del termine fascista è sintetizzato dal motto che decise di impiegare il Movimento Sociale Italiano: “non restaurare, non rinnegare”. Se da un lato la stretta autoritaria che stiamo sperimentando non deve essere minimizzata, non si deve agitare istericamente lo spettro del “ritorno” e di una restaurazione che non sembra possano – ne vogliano – intraprendere i nipotini del Duce. D’altra parte, bisogna comprendere come alcuni concetti politici forti abbiano due vite: la prima nell’esperienza storica cui sono legati, e l’altra nel significato e nei valori profondi che vanno ben oltre l’epoca e le circostanze specifiche in cui questi si sviluppano la prima volta. Non a caso Bertolt Brecht, riflettendo sulla natura del fascismo nei suoi diari, ipotizzò che, se il fascismo fosse mai giunto in America, questo avrebbe assunto sembianze democratiche. In conclusione, per quanto non si possa seriamente sostenere di vivere lo stesso clima dittatoriale del ventennio, non avrebbe senso rifiutare di chiamare Giorgia Meloni “fascista”, se non altro perché non si riconosce nell’appellativo opposto (antifascista).
Il problema semmai è chiedersi la ragione di questo revival reazionario a un secolo di distanza. Si possono avanzare numerose ipotesi, ma è fuor di dubbio che i motivi sono diversissimi rispetto a quelli degli anni ’20. Il fascismo come fenomeno europeo si sviluppò indubbiamente anche come reazione alla stagione di agitazioni rivoluzionarie del biennio 1919-1920. Si tratta di un’interpretazione comunemente accettata che è stata fatta propria anche da storici di estrema destra come Ernst Nolte (che pure la impiegava in termini giustificazionisti: una reazione legittima all’orrore del comunismo). È fin troppo evidente la stridente differenza con il nostro presente in cui non esiste un movimento di massa (né operaio, né studentesco, né di nessun altro tipo) contro il quale si sta organizzando una “reazione”. Non fraintendiamoci, i nuovi governi si stanno impegnando solertemente per reprimere quel poco che fatica a nascere, ma non ha senso prendersi in giro e raccontarsi di essere la regione della svolta autoritaria. Non è esagerato affermare che non esiste un’opposizione popolare nel mondo occidentale (e almeno in buona parte di quello extra-occidentale) che metta seriamente in crisi il potere costituito. La sperequazione nei rapporti di forza tra oppressi e oppressori è tale che occorre una particolare cautela nella proposta di qualsiasi analogia.
In virtù della mancanza di una opposizione politica ed egemonica al sistema vigente è difficile recuperare integralmente la nozione di “crisi organica” elaborata da Gramsci negli anni della prigionia[3]. Anche se la situazione economica contemporanea ricorda vagamente quella successiva alla crisi del ’29, con un ritorno al protezionismo[4] che può essere letto, con le parole di Gramsci, come una “resistenza reazionaria ai nuovi rapporti mondiali, all’intensificarsi del mercato mondiale”, il contesto politico è abbastanza differente. Anche la nozione di “cesarismo” va presa con le pinze visto che la “soluzione arbitrale” non deriva da una situazione in cui “le parti in lotta si equilibrano in modo catastrofico”. Alcuni elementi della politica cesarista si possono individuare: il rafforzamento degli esecutivi (che ha come corollario la burocratizzazione del legislativo) e la centralità del “capo carismatico” nel contesto di una vita politica spettacolarizzata. Ma tutti questi elementi si inseriscono nel quadro di una vittoria del capitale senza quasi nessuna battaglia prima; una vittoria che quindi è anche, e forse principalmente, culturale e ideologica. Non si vuole sostenere che la sconfitta storica del movimento operaio sia dovuta esclusivamente alla debolezza intellettuale dell’opposizione antisistema, sicuramente però, la mancanza di qualsiasi alternativa di sistema da un punto di vista ideale e teorico ha lasciato un’autostrada libera per il trionfo del neoliberalismo e dell’estrema destra.
Questo ci induce a mettere l’accento su un altro aspetto delle riflessioni di Gramsci, cioè al ruolo fondamentale che attribuisce agli intellettuali, soprattutto da un punto di vista “pedagogico”. Per Gramsci gli intellettuali (nel senso più lato del termine) avrebbero dovuto svolgere un ruolo “connettivo” ed “organizzativo” a stretto contatto con la classe lavoratrice, con le masse e con i subalterni. Solo attraverso questo collegamento avrebbe potuto penetrare nella società una nuova egemonia, premessa ineludibile per la rivoluzione in occidente. Si tratta di una riflessione particolarmente rilevante per chi, come noi, fa politica nell’Università di Bologna: un invito a considerare l’essere studenti come un impegno immediatamente politico, e al contempo un invito a non rinchiudersi nella “bolla” della città universitaria. Il processo di lunga durata che ha portato alla separazione degli intellettuali dal movimento reale, e quindi all’isolamento dei primi e alla scomparsa del secondo, è stato uno dei principali motivi della vittoria totale dell’ordine neoliberale prima, e del trionfo dell’estrema destra dopo; una delle ragioni per cui, da un certo momento in avanti, si è rinunciato a dar battaglia limitandosi alla “critica” dall’esterno del movimento. Potendo considerare la sconfitta storica del movimento operaio anche dal punto di vista della sua sconfitta culturale e ideologica, e quindi mettendo al primo posto la necessità di una nuova elaborazione teorica che sostenga un progetto combattivo, si deve rifiutare fermamente l’idea che ci si possa limitare a combattere con la penna: è un falso mito che possa ferire senza l’aiuto della spada. L’opposizione ai piani di guerra del nostro “nemico interno” passa inevitabilmente dalla ricostruzione di una forte connessione tra il mondo intellettuale militante e quello degli sfruttati.
1950
Anche la cosiddetta “Guerra fredda” presenta numerosi tratti in comune con il quadro internazionale dei giorni nostri. In primo luogo, maggior parte dei conflitti più recenti, dalla Siria all’Ucraina, non sono combattuti frontalmente da parte delle grandi potenze che dirigono il risiko mondiale. Maggior parte dei conflitti sono classificabili come “guerre per procura”, indipendentemente dal fatto che si presentino come “guerre civili” o “rivoluzioni”: in ogni guerra degli ultimi 30 anni almeno una delle parti in lotta è stata direttamente o indirettamente influenzata o controllata da Stati Uniti, Russia, UE o da altre potenze che intervengono nello scacchiere internazionale. Infatti, anche quei conflitti che hanno radici più profonde rispetto all’escalation di questi ultimi anni vengono inglobati e inquadrati all’interno della rivalità inter-imperialistica, assumendo talvolta questo duplice significato[5]. In secondo luogo, un fattore che non può non essere tenuto in considerazione è lo spettro dell’arma atomica, l’eredità più pesante della Guerra fredda che grava ancora sulle nostre teste come la spada di Damocle. È evidente che questo secondo elemento sia strettamente connesso al primo. Il deterrente della guerra atomica impone di combattere ai “margini” delle sfere di influenza visto che nessuno Stato può permettersi il rischio di ingaggiare uno scontro frontale.
Tra i vari conflitti “marginali” combattuti durante la guerra fredda, la Guerra di Corea (1950) si presta bene all’analogia. Prima che si giungesse alla distensione e alla “coesistenza pacifica”, la Corea fu il primo e il più intenso conflitto, in termini di spesa e di vite umane, combattuto non direttamente dai due blocchi. Sul 38° parallelo non si combatteva solamente una guerra civile, ma anche il primo confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel contesto del “contenimento” dell’espansione del campo socialista. Le analogie sono evidenti, e se ne possono tracciare di ulteriori dal momento che si è parlato abbastanza frequentemente di una possibile “soluzione coreana” al conflitto in Ucraina (ovvero la possibilità di una divisione del territorio conteso mentre prosegue un conflitto a bassa intensità).
A partire dalla guerra di Corea in Europa e in Italia si svilupparono dei movimenti che si mobilitavano preoccupati di una possibile escalation, fermamente contrari alla guerra e al coinvolgimento nei piani imperialisti degli Stati Uniti. In Italia il movimento prese il nome di “partigiani della pace”, tentando di costruire una continuità rispetto al movimento di liberazione di cui era molto viva la memoria. Consapevoli dell’importanza della solidarietà internazionale e dell’opposizione ai piani di guerra, numerosissimi militanti e cittadini impegnarono le loro migliori energie per fare breccia nell’opinione pubblica. Oltre ai “partigiani della pace”, e ben oltre la guerra di Corea, furono numerosissime le esperienze di diversa natura che si ponevano gli stessi obiettivi. Tra questi si possono citare l’esempio del Tribunale Russel promosso da Lelio Basso oppure l’esperienza dei movimenti antimperialisti contro la guerra in Vietnam. Il risultato fu duplice: si esercitò una effettiva pressione che facilitò in molti casi il ritiro delle truppe, e si rafforzò il movimento di massa che animò la stagione del lungo sessantotto. La solidarietà internazionalista si rivelava uno strumento fondamentale per fronteggiare l’imperialismo e per rafforzare il movimento anticapitalista; è così ancora oggi, e lo abbiamo sperimentato nelle piazze che si sono mobilitate per opporsi alle politiche colonialiste e genocidarie dello Stato israeliano.
La Guerra di Corea fu anche uno dei momenti più acuti della Guerra fredda, il primo in cui si ipotizzò seriamente la rappresaglia atomica contro la Cina, fiancheggiatrice della Corea del Nord. L’Unione Sovietica aveva da poco ottenuto l’arma nucleare per cui, ancora lontani dalla parità atomica, gli Stati Uniti avevano il coltello dalla parte del manico. Oggi che nove stati differenti dispongono dell’arma atomica la situazione non è migliorata, anzi, l’opzione nucleare è sempre presente, e nel dibattito pubblico se ne parla con una disinvoltura allarmante. Non ha senso perdersi ad immaginare ipotesi apocalittiche di una guerra termonucleare, ma è chiaro che la presenza degli arsenali nucleari è un problema oggettivo con cui bisogna confrontarsi. Per questo motivo può essere opportuno recuperare le riflessioni di chi per primo si confrontava con la possibilità di una guerra in uno scenario del genere. Nel 1959 il testo conclusivo del programma di Bad Godesberg della socialdemocrazia tedesca principiava così: “la principale contraddizione del nostro tempo consiste in questo: l’uomo ha scatenato la forza primigenia dell’atomo ed ora è terrorizzato dalle conseguenze di ciò”. Mentre si discuteva degli armamenti atomici nella Germania federale, la SPD, che pure con quel programma abbandonava qualsiasi prospettiva di lotta di classe, metteva in evidenza come la presenza dell’arma atomica stravolgesse completamente la politica internazionale. Anche Togliatti quattro anni più tardi avrebbe sollevato lo stesso problema in un famoso discorso poi intitolato “Il destino dell’uomo”: “l’uomo oggi, non può più soltanto, come nel passato, distruggere altri uomini. L’uomo può uccidere, può annientare l’umanità […] E la pace, a cui sempre si è pensato come ad un bene, diventa qualcosa di più e di diverso: diventa una necessità, se l’uomo non vuole annientare sé stesso.”
Nei mesi in cui si discute di un possibile riarmo europeo, nonostante non si parli ancora di un arsenale nucleare comune, le riflessioni di Bad Godesberg e di Togliatti rimangono utili ed attuali. La consapevolezza condivisa che una nuova guerra globale sarebbe stata devastante, e forse definitiva, portava a considerare la pace e la lotta contro il riarmo come una priorità inderogabile. Nonostante la parabola politica che stava già intraprendendo la SPD, oggi capofila dei partiti guerrafondai europei, il concetto espresso a Bad Godesberg ci sembra condivisibile: la necessità obbiettiva di mantenere la pace deve essere riaffermata con forza. La ricerca della pace però, non può essere uno slogan che si accompagna ad un supporto “critico” verso politiche militariste dell’Unione Europea (come fanno alcuni partiti a “sinistra” del PD), ma dev’essere una parola d’ordine con cui ricostruire un’opposizione antisistema. Essere per la pace, infatti, non vuol dire predicare la pace sociale. Occorre la piena consapevolezza che la pace può essere ottenuta solo con la lotta, non attraverso una lotta interstatale contro i nemici dei nostri governi, ma attraverso una lotta interna contro il nostro governo che vi si oppone. Per questo motivo, se proprio deve esserci una guerra, possiamo solo impegnarci affinché diventi civile visto che, come disse il partigiano Franco Venturi, “sono le sole che meritano di essere combattute”.
[1] La citazione integrale recita “Hegel nota in un passaggio delle sue opere che tutti i grandi fatti e grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa”
[2] Se il processo di decolonizzazione successivo alla Seconda Guerra Mondiale ha reso giuridicamente indipendenti la quasi totalità degli Stati del cosiddetto “Sud globale” (Palestina e Portorico sono forse le eccezioni più significative), non è cambiata la loro condizione di dipendenza rispetto a un pugno di paesi principalmente occidentali. Si può parlare in molti casi di ‘Neocolonialismo’ o di ‘Semi-colonialismo’, ma occorre cautela perché le differenti forme in cui si è riarticolato il rapporto di dipendenza tra centro e periferia sono differenti tra loro e sarebbe una forzatura rinchiuderle sotto un termine ombrello.
[3] Con una notevole semplificazione possiamo sintetizzare il concetto di “crisi organica” nel modo che segue: una situazione in cui la crisi economica e politica si avvicinano fino a fondersi, in cui la classe dominante perde la sua funzione dirigente e rimane solo dominante.
[4] La svolta protezionistica degli Stati Uniti non è iniziata con l’amministrazione Trump ma a partire dalla crisi del 2007-2008. «Del resto, è importante sottolineare, a questo riguardo, che la nuova politica protezionista americana non nasce a seguito di aggressioni militari o di svolte ulteriormente autoritarie nei paesi creditori, ma inizia a farsi strada molto prima, a partire dalla grande recessione del 2008 e dei problemi di debito conseguenti. L’attivatore del protezionismo è dunque la crisi finanziaria, che scatta prima del cosiddetto “trumpismo”.» Emiliano Brancaccio, Ignazio Visco, ‘Non-ordine’ economico mondiale, guerra e pace: un dibattito tra Emiliano Brancaccio e Ignazio Visco, in Moneta e Credito vol. 77 n. 308. p. 361
[5] Con questo non si vuole in alcun modo svalutare delle lotte di liberazione che rimangono guerre giuste a prescindere dal fatto che qualche potenza imperialista tenti di eterodirigere il popolo oppresso. Vale per la Palestina quanto per il Kurdistan.

Mi piace molto questo articolo