[di Manfredi]
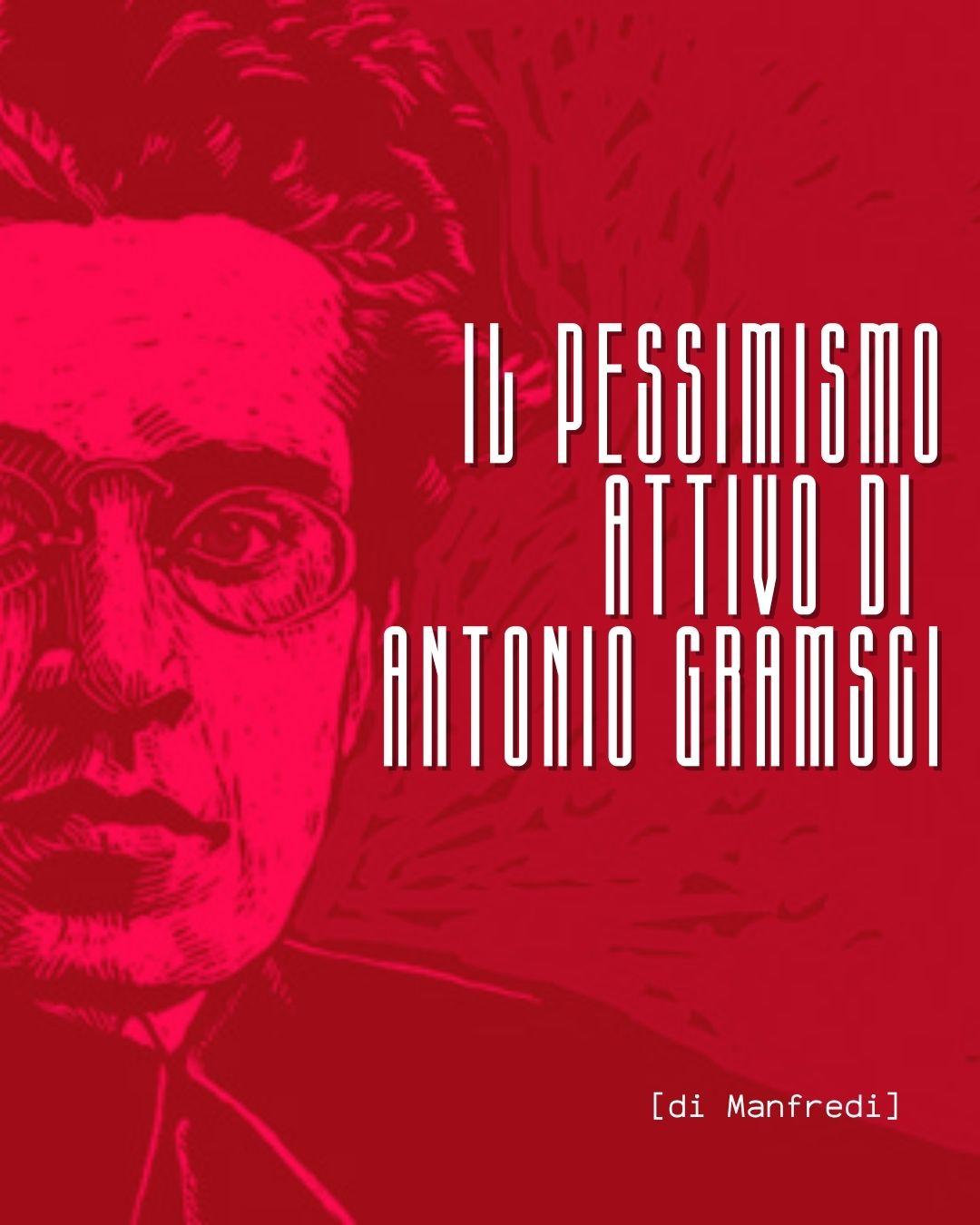
Nel corso della produzione di Antonio Gramsci a partire dal 1920 ricorre più volte un’espressione di Romain Rolland: “pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”1.
Nei quaderni si ritrova come critica all’attitudine di chi è pronto a tralasciare di considerare le condizioni oggettive, i fatti e la storia quando gli fa più comodo, per gettarsi in imprese velleitarie in cui la volontà non ha sostanza da cui partire. Al contempo, si volge contro coloro che al primo impedimento si nascondono al riparo di quelle stesse condizioni oggettive, della necessità storica, per gettare la spugna e rimettere il proprio compito a qualche fantomatico automatismo della storia. A questo “ottimismo dell’intelligenza” (dove l’intelligenza è il regno dei fatti e delle leggi storiche, il corpo logico del marxismo) Gramsci contrappone un “ottimismo della volontà”, appunto.
E’ in un certo senso un mantra morale per l’attitudine del militante, destinato a diventare sempre più rilevante con il montare della forza fascista, nel momento più buio in cui aggrapparsi a false speranze
(come nella famosa “svolta” del 1930, che tanto innervosì il prigioniero Gramsci) o lasciarsi affondare nella disperazione diviene più facile: “ogni collasso porta con sé disordine intellettuale e morale. Bisogna creare gente sobria, paziente, che non disperi dinanzi ai peggiori orrori e non si esalti a ogni sciocchezza, pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”2.
Ma anche in precedenza l’espressione era stata utilizzata nella sua accezione più diretta, morale e quasi pedagogica. Nel 1920 compare nell’Ordine Nuovo esplicitamente come “parola d’ordine di ogni comunista consapevole degli sforzi e dei sacrifizi che sono domandati a chi volontariamente si è assunto un posto di militante nelle fila della classe operaia”3. Gramsci qui si rivolge a un partito, il PSI, che con le sue contraddizioni ci aiuta a individuare il significato di questa frase al di là del suo senso immediato, collocandola nel quadro più ampio delle esigenze politiche del Gruppo dell’Ordine Nuovo e delle conseguenze ancora fresche della rivoluzione d’ottobre. Quello di Gramsci è un pessimismo attivo, come rilevato da Badaloni, che nasce dalla ricezione del leninismo e dal porsi in opposizione alle deformazioni del movimento socialista del suo tempo.
Gramsci è esposto agli scritti di Lenin quando, nel 1918, iniziano ad essere tradotti in italiano e a comparire nel paese; gli daranno gli strumenti per trarre una lezione proficua, capace di svilupparsi in una visione coerente e tattica concreta, tratta dagli eventi dell’ottobre. La rivoluzione russa presenta “una realizzazione politica non mediata dai [ritenuti] necessari momenti del suo sviluppo”, mettendo in crisi a destra gli incancrenamenti parlamentaristi e dottrinali dei grandi nomi della seconda internazionale e al contempo scuote “i revisionisti di sinistra, ai quali, in luogo del mito o della aspettazione del crollo” impone “compiti di costruzione politica”4.
La prima critica è quindi mossa a coloro che avevano abbandonato lo sforzo concreto di preparazione a un momento rivoluzionario per concentrarsi sulla tattica elettorale, concezione che lasciava trapelare un ottimismo dell’intelligenza, e quindi l’attitudine a cercare nell’ordine logico del marxismo una soluzione sufficiente al problema del periodo di transizione al socialismo. Ne seguiva come conseguenza una depressione della volontà, una scarsa cura della costituzione dell’elemento soggettivo che potesse scalzare l’ordine sociale esistente. Se le leggi della storia, nel proprio svolgersi, sono imperturbate da sforzi volontari tanto da parte della nuova classe che sorge quanto da parte della vecchia classe che tramonta, i revisionisti della seconda internazionale pensavano di poter aspettare che le contraddizioni del capitalismo sfociassero nel suo superamento senza che alcuna forza soggettiva dovesse farsene carico oltre alla prospettiva di conquista dell’apparato statale borghese (che si riteneva potesse essere trasformato e mantenuto nella transizione al socialismo) nei limiti della legalità. La smentita verrà prima dall’ottobre poi, tragicamente, dalla capacità della borghesia di organizzare la sua reazione nel fascismo e nel nazismo.
All’interno del PSI, questa critica si può estendere anche ai massimalisti guidati da Serrati. La fiducia cieca nei confronti di uno sbocco rivoluzionario, che dopo la grande guerra sembrava dietro l’angolo, non si traduceva in nient’altro che retorica, mancando una seria volontà di essere l’avanguardia alla testa di questi sviluppi. L’impotenza di fronte alla effettiva crisi rivoluzionaria rappresentata dal biennio rosso testimonierà il potere disarmante della fede nel sol dell’avvenire quando non accompagnata dalla volontà di svolgere un ruolo di avanguardia effettiva e nazionale, di forza soggettiva. Questa posizione intermedia, rivoluzionaria a parole ma riformista nei fatti, aveva conquistato la maggioranza nel congresso di Bologna del 1919 con il 65% dei voti ma rimaneva un corpo inerte, non disposto a cacciare i Turati, Treves e Kuliscioff anche quando l’espulsione dei riformisti era diventata condizione vincolante per l’adesione alla terza internazionale5. Di nuovo un ottimismo della lettura del piano logico del marxismo sbocca in una castrazione dell’importanza data all’elemento “volontario” dell’organizzazione soggettiva.
Anche nelle frange del PSI che convergono a Livorno per costituire il PCd’I nel 1921 però troviamo una situazione problematica. Bordiga è a tutti gli effetti il principale punto di riferimento del nuovo partito, supportato perfino dai compagni torinesi di Gramsci. Togliatti stesso scrive (riferendosi a sé in terza persona) : “ciò che più sorprende e deve essere registrato con attenzione è che finirono per capitolare davanti a una concezione settaria del partito [si fa riferimento alla linea di Bordiga] anche quei compagni come Terracini e Togliatti che, accanto a Gramsci e sotto la sua direzione non solo avevano seguito un opposto indirizzo di lavoro, ma avevano dato un contributo all’elaborazione di ben diverse concezioni e ad esse si erano ispirati nel corso di azioni di notevole rilievo”6. Lo stesso Gramsci fatica a far valere le sue critiche, tanto da limitarle perlopiù (prima del suo richiamo a Mosca) alle occasioni private. Il problema centrale delle tesi di Bordiga in questa fase è il suo antielettoralismo, già criticato da Lenin durante il secondo congresso dell’internazionale7, che è però condiviso dalla maggioranza. Non si tratta che di una conseguenza di una più generale impronta dogmatica data alla lettura del marxismo, che lasciava al corredo logico e ai concetti ben più spazio che all’analisi storica. Risulta centrale il concetto bordighiano di una linea storica invariante del marxismo, un’insieme di “posizioni programmatiche e di principio” (come le definisce Gramsci stesso nei quaderni) a cui il proletariato si sarebbe dovuto naturalmente avvicinare sotto la spinta delle condizioni oggettive. Il prodotto pratico di questa strategia è un sostanziale isolamento dalla massa, aspettando che la montagna vada da Maometto.
Gramsci risponde a questa concezione del partito con una posizione marcatamente leninista: il partito non può svolgere il suo ruolo dall’esterno della società, aspettando passivamente che le leggi storiche la conformino ad esso, al contrario, deve essere un attore organico del processo storico. Questo significa avvicinarsi alla classe con una tattica conforme alla sua condizione presente (ad esempio, mediante la critica in sede parlamentare) garantendosi una posizione di internità e un ruolo di avanguardia. Si tratta sempre di ristabilire il rapporto tra comparto logico e azione politica, rendersi conto che il primo è al servizio della seconda quanto la seconda è finalizzata sulla base del primo. Bordiga non elimina il primato fondamentale della analisi sociale nella politica e filosofia materialista, ma lo declina in modo da non poterne trarre posizioni tattiche adeguate alla situazione corrente: formula una strategia unica “pura” tratta dai caratteri generali del capitalismo contro cui porsi con intransigenza, dimenticando di considerare la maturazione della componente soggettiva e il reale rapporto tutt’altro che monolitico e univoco tra le classi in lotta e quei settori sociali che il proletariato deve vincere alla sua linea (specialmente in un paese rurale come l’Italia di inizio Novecento) per ottenere il successo nella lotta per il potere.
Insomma Gramsci trae dalla leninista “restaurazione della dialettica rivoluzionaria contro l’astratto argomentare formalistico dei pedanti, degli sciocchi e degli sviati […], un solido fondamento [per la] ricerca e la lotta che può essere condotta per inserire nelle contraddizioni del regime borghese la lotta della classe operaia, in modo che apra una via rivoluzionaria”8. La questione è direttamente tematizzata in “Contro il pessimismo”, un articolo uscito sull’Ordine nuovo del 15 marzo 1924. Il titolo potrebbe far alzare un sopracciglio: non si è detto fino a qui che Gramsci è quello che si può chiamare un “pessimista attivo”? La questione è subito risolta: il pessimismo su cui qui si scaglia Gramsci è fin dalle prime righe chiaramente il pessimismo morale e politico che porta all’immobilismo – il pessimismo della volontà, insomma. Si tratta non solo di qualcosa da allontanare, ma del pericolo “più grande forse del momento attuale, per le sue conseguenze di passività politica, di torpore intellettuale, di scetticismo verso l’avvenire”9. Quando si prendono in considerazione le cause di questo pessimismo inibitorio (e inibitorio proprio della “volontà” comunista rispetto alla “tradizione”10 socialista, in riferimento a tutto il ciarpame massimalista e oggettivista che Gramsci voleva il partito di Livorno si lasciasse indietro senza strascichi) è ancora più chiaro come la posizione qui esposta rientri coerentemente nel quadro che abbiamo descritto fino ad ora. Gramsci teme infatti cosa sarebbe dei comunisti se “ci abbandonassimo al fatalismo, ci cullassimo nella dolce illusione che gli avvenimenti non possono che svolgersi secondo una determinata linea di sviluppo”11. Questa è proprio una critica del pessimismo della volontà ed è tanto più tagliente quando si prende in considerazione il contesto in cui Gramsci scrive a un partito ancora largamente ancorato su posizioni bordighiste.
L’appello di Gramsci è a un “maggior senso di responsabilità […] con la preoccupazione fattiva di apprestare forze organizzative e materiali idonee per parare ogni evenienza”12. Responsabilità qui è la parola chiave, perché è la responsabilità delle forze soggettive di fronte alla storia, una responsabilità che frantuma i vecchi e nuovi schemi intellettualistici e dogmatici di fronte all’evidenza politica del ruolo che spetta ai comunisti nel momento presente. E’ una vera e propria rivoluzione copernicana del materialismo storico, che mette il momento del politico al centro, da che orbitava attorno al piano logico.
Ecco che il pessimismo attivo di Gramsci prende una forma tutt’altro che limitata all’attitudine individuale: bisogna, a partire da un’analisi lucida e priva di illusioni della realtà presente (il pessimismo dell’intelligenza), costruire una linea tattica che vi sia aderente e volga a trasformarla mediante un intervento interno ad essa (l’ottimismo della volontà). Con le parole di Togliatti, che parafrasa Gramsci stesso, “la realtà, il presente, diventa una cosa dura su cui occorre violentemente attirare l’attenzione, se si vuole trasformarla”13. Non si tratta più della “parola d’ordine” di ogni singolo militante, ma della natura e dell’importanza della tattica per il raggiungimento del fine strategico, cioè la forma effettiva e reale che prende la realizzazione del ruolo storico rivoluzionario del proletariato. “La linea politica del partito resta astratta se non si articola in tattica”14, questo era stato a conti fatti lo scoglio posto dai massimalisti prima e dai bordighisti poi ma al contempo non si deve peccare nella direzione opposta. Lo sforzo soggettivo del partito non è volontarismo velleitario. L’aspetto “pessimista” del leninismo sta anche nel ferreo impegno nell’analisi del reale necessaria a sostanziare questa spinta volontaria, è l’impegno quasi violento a non scindere la teoria dalla prassi e la prassi dalla materialità dell’impegno teorico: la realtà e l’azione del partito sono separabili solo nell’astrazione e l’unico modo di mantenere la consapevolezza di questa unità di fatto è incanalare l’esuberanza dell’immaginazione politica della classe fondamentale su binari informati teoreticamente e saldi sulla realtà sociale in cui si opera. “Il solo entusiasmo giustificato è quello che accompagna la volontà intelligente , l’operosità intelligente, la ricchezza inventiva in iniziative concrete che modificano la realtà esistente”16.
Il pessimismo attivo di Gramsci viene sì da Lenin, ma non è un calco del suo pensiero e non è privo di influenze più legate al panorama intellettuale italiano di quel tempo. Per il discorso qui affrontato l’influsso dell’anti-determinismo di Sorel è particolarmente interessante, con la consapevolezza che non si tratta di ridurre a questo la questione, o di stabilire una derivazione privilegiata dell’assetto gramsciano da Sorel. Tra la fine dell’ottocento e i primi anni del Novecento Sorel affronta il rapporto tra effettiva pratica politica e scienza economico-astratta, da intendersi come la forza logica e concettuale del marxismo.
Per quel che riguarda quest’ultima “si tratta di dare luce completa ai concetti, mostrando come essi si comportano quando funzionano in modo teorico, cioè senza alcuna complicazione estranea”16, ovvero come i concetti, che in questo caso sono le leggi e le forme storiche prese in considerazione dall’analisi sociale, si relazionino e agiscano in un piano logico puro ripulito dall’effettivo svolgimento nella storia. Naturalmente questo modo di intendere l’anima scientifica della filosofia sociale, che Sorel imputa al “socialismo ipergiuridico dei nostri dottori in alta politica riformistica”17 della seconda internazionale non ha implicazioni pratiche e apre di conseguenza la strada a deviazioni revisioniste sulla natura della lotta politica. Sorel sente quindi che per ottenere uno sbocco reale delle lotte è necessario uscire dall’impianto innanzitutto teoretico in cui si era incagliato il socialismo di quegli anni, e ridare invece spessore alla pratica politica. Questo sfocia, nel pensiero del sindacalista francese, in una biasimabile opposizione agli intellettuali tout court, “tuttavia il modello logico non può venir meno senza trascinare con sé la fiducia nel carattere rivoluzionario della transizione”18 al socialismo. Senza una scienza sociale che sappia trascendere la lotta per rivendicazioni immediate si scade, cioè, nell’economicismo senza superare il quadro del corrente modo di produzione. C’è quindi bisogno di ricucire l’ordine logico all’ordine storico-politico dell’azione della classe organizzata. La risposta che troverà Sorel, sebbene avanzata rispetto alle conclusioni che Croce e Pareto avevano tratto dall’inefficacia dell’ordine logico nel rappresentare la storia, resta insufficiente. Fortemente viziata da aspetti letterari, la prospettiva di Sorel è di far rivivere l’ordine logico in un “mito”, in una “spinta volontaria” che si materializzerebbe poi storicamente attraverso l’attività sindacale e innanzitutto lo sciopero generale. Non si accetta la capacità effettiva dell’ordine logico di determinare o predire con sicurezza le forme della transizione al socialismo, ma al contempo volendo mantenere uno sbocco rivoluzionario nel suo fondamento scientifico – e quindi la validità dell’ordine logico – lo si fa riapparire “come mito prospettiva” e “lo [si] ricostituisce sotto la spinta dell’elemento volontario”19. E’ come se, riconosciuta la necessità di una teoria rivoluzionaria che trascenda la azione politica immediata, la si volesse far tornare dalla finestra come utile fede senza spiegarne scientificamente il fondamento.
Questa ricomposizione operata da Sorel sarà ripresa da Gramsci che, attraverso il pensiero di Lenin, saprà individuarne le “deformazioni letterarie”20 e correggerle, mantenendo l’atteggiamento di fondo. Quando la mitologia dello sciopero di Sorel fallirà di fronte al crescente indirizzo riformista delle organizzazioni sindacali, tanto che Sorel stesso si allontanerà amareggiato dal movimento per inseguire la sua “spinta mitica” in derive nazionaliste, mentre i suoi seguaci italiani passeranno al fascismo, Gramsci saprà riaprire la problematica fondamentale dell’ordine logico del marxismo per come inteso dal revisionismo secondinternazionalista. Il problema fondamentale rilevato dal francese stava nel mettere l’ottimismo nei confronti delle leggi storiche alla testa della considerazione dell’effettiva forma e natura dell’organizzazione della classe. Citando Sorel “ciò che vi è di più profondo nel pessimismo è il modo di concepire la marcia verso la liberazione. L’uomo non andrebbe lontano , nell’esame delle leggi della sua miseria e della fatalità, che colpiscono tanto l’ingenuità del nostro orgoglio, se non avesse la speranza di venire a capo di queste tirannie con uno sforzo che egli tenterà con tutto un gruppo di compagni”21.
L’elemento di maturità che Gramsci dà a questa prospettiva sta nel riconoscere il vincolo posto dalla struttura, la sua direzionalità e il legame di questa con i soggetti operanti della storia: niente più salti mortali mitologici, ma una scienza di forze attive in conflitto tra loro, in cui l’azione dei gruppi in lotta per ottenere la vittoria conforme allo sviluppo della struttura non è una necessità libresca, ma una tattica efficace e il primo oggetto della scienza politica. Gramsci riprende il sorelismo per la sua potenzialità antiriformista e antipositivista, ma armato del leninismo ne ricava una tattica concreta (o meglio: una capacità di produrre tattica concreta) per l’azione nel processo storico. Riscopre così l’importanza del politico: mentre Sorel aveva pensato che l’opposizione al determinismo meccanico passasse per una visione narrativa della storia22, Gramsci è invece cosciente che la battaglia si combatte nel campo dello sviluppo delle forze di produzione, ma tramite lo strumento politico dell’organizzazione soggettiva come espressione delle contraddizioni strutturali del sistema di produzione.
Il “connotato di necessità dell’economico” resta saldo e si tratta invece di realizzare il “blocco storico”, ovvero “l’unità dell’articolazione delle forze produttive oggettive e di quelle soggettive”23. Si rivendica l’unità fondamentale del processo storico già posta da Labriola, e tramite questa unità si riconosce come non solo la sovrastruttura sia determinata dalla struttura, ma anche la coscienza e l’azione delle forze soggettive partecipano a pieno titolo allo svolgersi della storia.
Quello di Gramsci non è un volontarismo radicale, inclinazione che considerava solo un’altra forma di ottimismo puerile, figlio di una mancanza di organicità alla classe e dell’avventurismo piccolo borghese.24 Si tratta invece del rilievo dato alla costituzione di una tattica politica conforme allo sviluppo delle forze di produzione che sappia costruire il “blocco storico” contrapposto a unilateralismi dogmatici o revisionisti e agli sforzi mitici del sindacalismo soreliano. Questo vuol dire anche riconoscere la possibilità di una reazione controrivoluzionaria alla costituzione del corpo soggettivo della classe lavoratrice e constatare che un fallimento nella costituzione del “blocco”, come nel caso del PSI rispetto al biennio rosso, possa portare a disgregazione delle forze di questa classe e aprire la strada alla reazione. Il senso del pessimismo attivo non è un vacuo incoraggiamento a “lavorare di buona lena”, ma l’essere consapevoli che le forze storiche hanno una realtà profonda a cui il partito deve sapersi legare, e che dall’operato di questi attori soggettivi dipende il successo o l’insuccesso della lotta di classe in una determinata fase. Non lo si può mettere meglio che Gramsci stesso: “L’automatismo storico di certe premesse (l’esistenza di certe condizioni obiettive) viene potenziato politicamente dai partiti e dagli uomini capaci: la loro assenza o deficienza (quantitativa e qualitativa) rende sterile l’automatismo stesso (che non è più automatismo): ci sono astrattamente le premesse, ma le conseguenze non si realizzano perché il fattore umano manca”25. Ecco il punto della questione, che deve aprire serie riflessioni sulla necessità e la natura di un partito comunista in un momento, come quello odierno, di grande arretratezza delle forze soggettive.
Il valore politico di un partito si valuta nella sua capacità di incidere nella società, ma in questo campo non ha niente a che vedere con le deformazioni operate da Togliatti nel suo pensiero del “partito nuovo”. Quando questi legge nel quaderno tredici che “un partito avrà avuto maggiore o minore significato e peso, nella misura appunto in cui la sua particolare attività avrà pesato più o meno nella determinazione della storia di un paese”26 vuole leggervi un invito a fare del partito comunista una forza capace di incidere nel gioco politico del paese, assumendo che il proletariato, ertosi dopo la caduta del fascismo a classe nazionale, abbia pressoché concluso il processo di costituzione delle sue istituzioni private e si tratti ora di vincere nel campo costituzionale di una “democrazia progressiva” il supporto delle masse a queste istituzioni. Si tratta di un pensiero che non ha nulla a che vedere con quello che Gramsci considerava il ruolo del partito, che culminerà nelle pretese di governo del PCI sotto Berlinguer. Quando Gramsci parla di “determinazione della storia di un paese”, rispetto a un partito Comunista, andrebbe ricordato che l’orizzonte della lotta per Gramsci è la costituzione di un potere separato del proletariato, allargato al campo della politica e della cultura. Gramsci opera questa scissione nell’orizzonte del ricongiungimento nel blocco storico, è evidente che non c’è nulla qui del politicismo e dell’elettoralismo togliattiano, che viola la concezione ben più correttamente leninista della società come campo dinamico di lotta in cui la politica è strumento per spingere i rapporti di forza tra attori storici titanici quali sono le classi, per una lotta per il potere e l’egemonia che di sicuro non si risolve nell’attuazione della costituzione.
Gramsci ha visto la miseria del riformismo e la necessità di costruire un partito comunista per superarlo, ha visto poi il fascismo smantellare il movimento operaio, la fine delle sue organizzazioni di massa e il letargo che ne è conseguito. Queste esperienze lo hanno reso conscio dell’importanza dell’organizzazione e di una linea politica corretta: di fronte agli esiti catastrofici che la sua mancanza determina, si rende palese l’importanza di un partito di quadri capace di svolgere il ruolo di intellettuale collettivo della classe fondamentale e di agire con abilità nella pratica per attuare e diffondere le proprie linee. Al contempo però, il pensiero di Gramsci non dimentica mai di poggiare i piedi sullo studio della società e del suo modo di produzione, e sa allora che le forze della storia non vanno in letargo, che le contraddizioni del capitalismo non smettono mai di costruire le condizioni per il suo superamento. Allora il compito della classe operaia che marcia verso il socialismo è la produzione di quadri competenti e legati da una linea rigorosa senza essere rigida, per la costituzione di un partito che sappia essere tattico senza perdere di vista il proprio orizzonte strategico. La parola d’ordine degli attori di questo processo, tanto nella loro attitudine militante quanto nella concezione del compito storico della loro organizzazione deve essere ancora “pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”.
- In realtà non è stata trovata nelle opere dell’autore, ma Valentino Gerratana ritiene probabile l’attribuzione di Gramsci sia corretta, visto che un’espressione simile è effettivamente rintracciabile nelle memorie di Malwida von Meysenburg, con cui Rolland era in confidenza.
- A. Gramsci, Quaderni del Carcere, Q.1 p. 75.
- In A. Gramsci, Quaderni del carcere, apparato critico p.2510, da Ordine nuovo n.404, 4- N. Badaloni, Il marxismo di Gramsci, p.99.
- Addirittura nei famosi 21 punti per l’adesione all’internazionale redatti da Lenin stesso per il suo secondo congresso, al punto 7 si legge rispetto a ciò un riferimento diretto al caso italiano: “l’Internazionale non può più tollerare che dei riformisti dichiarati come ad esempio Turati, Modigiani ecc. abbiano il diritto di considerarsi membri della III Internazionale. Se così fosse l’Internazionale finirebbe per somigliare in larga misura alla defunta II Internazionale”.
- In G. Fiori, Vita di Antonio Gramsci, p.179.
- “Solo quando si è membri del parlamento borghese si può combattere – partendo dalle condizioni storiche esistenti – la società borghese e il parlamentarismo. Lo stesso mezzo che la borghesia utilizza nella lotta deve essere adoperato – s’intende per fini del tutto diversi – anche dal proletariato. Voi non potete contestare che sia così; ma, se volete contestarlo, dovete prescindere dalle esperienze di tutti gli avvenimenti rivoluzionari del mondo”, dalla replica di Lenin a Bordiga nel secondo congresso dell’Internazionale.
- In Gramsci, l’Italia, il Socialismo – quattro scritti di Palmiro Togliatti, P. Togliatti, Il leninismo nel pensiero e nell’azione di Gramsci.
- In Il pensiero di Gramsci, a cura di C. Salinari, M. Spinella, p.175. A. Gramsci, Contro il pessimismo
- Ibidem.
- Ivi, p.176.
12 – Ivi, pp. 175, 176.
- Ivi, parafrasando Quaderni del Carcere, Q.9 p.1131. L’uso della versione ripresa da Togliatti è ragionato solo sulla maggiore compattezza.
- L. Gruppi, La concezione del partito rivoluzionario
- A. Gramsci, Quaderni del carcere, Q.9 p.1192
- In N. Badaloni, Il marxismo di Gramsci, p.56, da G. Sorel, Introduction à la economie politique.
- Ivi, p.58, da G. Sorel, Introduction à la economie politique.
- N. Badaloni, Il marxismo di Gramsci, p.58.
- Ivi, p.59.
- Ivi, p.61.
- In N. Badaloni, Il marxismo di Gramsci, p.61, da G. Sorel, Considerazioni sulla violenza
- Addirittura il potenziale reazionario per Sorel sta nella possibilità che la storia faccia passi indietro, e vedeva in questo modo il capitalismo monopolistico come un ritorno alle pratiche del mercantilismo.
- N. Badaloni, Il marxismo di Gramsci, p.152 24- cfr A. Gramsci, Quaderni del carcere, Q.13 p. 1624 25- Ivi, Q.13 p.1627, le parentesi sono di Gramsci.
26- Ivi, Q.13 p. 1630
BIBLIOGRAFIA
- A. Gramsci, a cura di V. Gerratana, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2014. – N. Badaloni, Il marxismo di Gramsci, Einaudi, Torino 1975.
- G. Fiori, Vita di Antonio Gramsci, L’Unità / Laterza, Trento 1966.
- In Il pensiero di Gramsci, a cura di C. Salinari, M. Spinella, Editori Riuniti, Roma 1977, A. Gramsci, Contro il Pessimismo.
- In Critica marxista 2-3 1987, Editori Riuniti, Roma 1987, L. Gruppi La concezione del partito rivoluzionario.
- In Gramsci, l’Italia, il Socialismo – quattro scritti di Palmiro Togliatti, Allegato all’almanacco PCI, 1977, P. Togliatti, Il leninismo nel pensiero e nell’azione di Gramsci.
